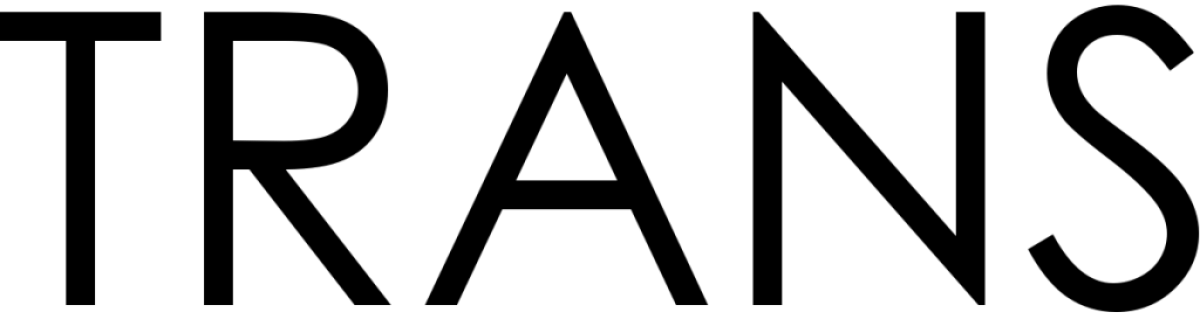Iride Valenti
(Università degli Studi di Catania)
iridevalenti@unict.it
Abstract
Gegenstand des vorliegenden Beitrags bilden Erzählungen von Italo-Tunesier*innen, die derzeit in Tunesien leben, sowie von Nachkommen italienischstämmiger (meist sizilianischer) Familien, die zuvor nach Tunesien ausgewandert sind. Im Fokus der Untersuchung stehen insbesondere Sprecher*innen der 2. Generation (die über 75 Jahre alt sind) und der 3. Generation (55-75 Jahre), die zwischen 2018 und 2022 interviewt wurden. Ziel war es, den Prozess der Italianisierung und später der Französisierung von Italiener*innen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts nach Tunesien emigrierten, aufzuzeigen.
Nel presente contributo l’attenzione si concentra sulle produzioni orali (da me raccolte tra il 2018 e il 2022) di alcuni parlanti italotunisini attualmente residenti in Tunisia e discendenti da famiglie di origine italiana (per lo più siciliana) emigrate nel Paese nord-africano nella seconda metà dell’Ottocento. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza gli indizi del processo di italianizzazione, prima, e di francesizzazione, poi, che nel corso del Novecento interessò gli italiani emigrati in Tunisia, ridimensionando, com’era inevitabile, l’uso del siciliano (progressivamente rimasto confinato ai contesti familiari), pur senza cancellarne alcuni tratti fonologici salienti.
In this contribution, the focus is on the direct testimonies of some Italo-Tunisian speakers currently resident in Tunisia and descendants of families of Italian origins (mostly Sicilian) who previously emigrated to Tunisia. We chose in particular to focus on 2nd generation speakers (aged over 75) and 3rd generation speakers (aged between 55 and 75), whose testimonies were collected between 2018 and 2022. The aim was to highlight the evidence of the process of Italianisation, first, and then Frenchisation, that affected Italians who emigrated to Tunisia during the 20th century.
1. Uno sguardo alla storia (misconosciuta) degli italiani in Tunisia
La campagna di inchieste linguistiche da me condotta tra il 2018 e il 20221 mi ha consentito di entrare in contatto con un lembo della storia – anche linguistica – dell’Italia a lungo ignorato, quantomeno nei libri di storia usualmente studiati a scuola. Si parla molto poco, infatti, dell’emigrazione italiana in Tunisia, avviatasi prima dei grandi traffici transoceanici e ben prima dei consistenti flussi degli anni ’50 e ’60 del Novecento. Eppure, tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento, moltissimi italiani originari della Sicilia2 (oltre che sardi e, in misura minore, calabresi) continuarono ad attraversare il mare, come era avvenuto senza soluzione di continuità nel corso di tutto il XIX sec.3, e si stabilirono in Tunisia4.
Dell’argomento mi sono occupata anche altrove, sia prendendo spunto dalle peculiarità della lingua letteraria dei primi romanzi – La riva lontana (Sellerio 2000), La traversata del deserto (Arkadia 2014) e L’erba di vento (Arkadia, 2016) – della scrittrice italotunisina Marinette Pendola (Valenti 2019 e 2021), sia soffermandomi sull’autobiografia linguistica contenuta nel romanzo memorialistico di Marcello Bivona L’ultima generazione (Valenti 2022b), sia analizzando le produzioni orali di alcuni italotunisini (Valenti 2022a). Limitandomi in questa sede a brevi cenni introduttivi relativi alla storia dell’emigrazione italiana in Tunisia, rinvio a tali contributi in particolare per le considerazioni di taglio linguistico, ancora pressoché uniche nel panorama degli studi.
Sorvolando sulla presenza secolare di italiani (veneziani, genovesi, pisani, fiorentini, napoletani, palermitani) in Tunisia, e in generale in altri Paesi dell’Africa settentrionale almeno dal XII sec. (Jehel 2001)5, è qui opportuno ricordare che dal XVII sec., e particolarmente nella prima metà del XIX sec., affluirono in Tunisia italiani provenienti da Toscana, Liguria, Sardegna e Piemonte, anche grazie alla stipula, fra il 1816 e il 1822, di trattati favorevoli tra la Tunisia e gli Stati italiani, che bloccarono le abituali incursioni, ad opera dei tunisini, nel Granducato di Toscana e nei regni di Sardegna e di Napoli (Atzeni 2011: 785 e ss.; Speziale 2016: 19-20). Tali gruppi mantennero posizioni di prestigio nell’economia e nei commerci e, conseguentemente, nella vita sociale tunisina. Ad essi si aggiunsero nella prima metà dell’Ottocento anche altri rifugiati italiani politici (napoletani, siciliani, liguri, lombardi, romagnoli, piemontesi, lombardi, toscani)6, unitamente ad altri commercianti e artigiani toscani (particolarmente ebrei livornesi)7, liguri, sardi, siciliani. Si può ancora ricordare il ruolo che ebbero medici e farmacisti italiani agli inizi dell’Ottocento, «lorsque les Beys ont encouragé leur venue, pour être les premiers béneficiaires de leurs services» (Campisi 2020: 122), al punto che, nel 1835, il Bey nominò il dott. A. Lumbroso (giudeo livornese) Direttore generale del Servizio Sanitario e, nei decenni successivi, fu creato un primo ospedale a Tunisi nel 1890, dieci anni prima del secondo ospedale italiano intitolato a “Giuseppe Garibaldi” (Campisi ibid.; cfr. Boccara 2000). Nella prima metà dell’Ottocento, gli italiani presenti in Tunisia erano circa 6.000 (Finzi 2000: 41).
Nel 1868 grazie a un accordo tra il Re d’Italia e il Bey di Tunisi, agli italiani era stata garantita libertà di commercio e di industria, di acquisire beni immobili e terre agricole, pur mantenendo la propria nazionalità e l’immunità giuridica, sotto il controllo del Consolato italiano. Di lì a poco, sul finire del XIX sec. – in relazione alla crisi economica dell’Italia – partendo dalla Sicilia, ma anche da Calabria, Puglia e Sardegna, braccianti e contadini, pescatori, artigiani, minatori, manovali, piccoli commercianti raggiunsero la Tunisia in gran numero. L’esodo fu dapprima (nel corso dell’Ottocento) in forma stagionale, poi sempre più stanziale dopo l’Unità d’Italia (Speziale 2016: 39-40)8. La vicinanza tra le due sponde del Mediterraneo, quella italiana e quella tunisina, favorì una migrazione caratterizzata da quelle che, con Turchetta 2018: 82, possiamo identificare come “catene migratorie lunghe e articolate”. Nel contesto tunisino vennero a inserirsi intere famiglie, spesso provenienti dalle stesse località da dove già altri prima erano partiti e altri si accingevano a partire (si pensi alla ricostruzione che di simili processi è dato fare grazie ai racconti autobiografico-memorialistici di Marinette Pendola 2000c e 2014). Al riguardo, è il caso di ritornare su quanto scrive Masi (2014: 28):
[l]a prospettiva africana, assecondata, peraltro, dal trattato della Goletta (1868), aveva un’angolazione vantaggiosa. Dal Governatore ottomano si otteneva una convenzione in grado di garantire svariati privilegi, il trattamento di comunità più favorita dal punto di vista commerciale che prevedeva per gli italiani il libero esercizio delle professioni, il riconoscimento delle scuole e dell’associazionismo esistente. […] La ripresa della politica espansionistica attuata dalla Francia, con la conquista di Tunisi nel 1881, bloccò ogni velleitarismo, per cui le concessioni furono abolite e l’emigrazione da commerciale si trasformò in proletaria, in un’emigrazione generica che si trasferì nel paese maghrebino, perché invogliata dall’intensificazione dei lavori promossi dai nuovi reggenti.
Si passò così dai 6.000 italiani presenti in Tunisia ancora intorno alla metà dell‘Ottocento, ai 25.000 del 1881 (Atzeni 2011, 800)9, agli oltre 100.000 dei primi del Novecento (Davin 1910: 691; cfr. anche Melfa 2006: 121-148 e Campisi 2020: 121).
Nell’ambito di questo massiccio flusso migratorio, alcuni italiani si stabilirono a Tunisi e in altri centri urbani costieri (ad es. Sousse o Biserta), lavorando come pescatori, artigiani, manovali e nel commercio; altri raggiunsero le campagne, riuscendo progressivamente a diventare – come avvenne ad es. al padre della stessa Marinette Pendola – proprietari di piccole aziende agricole.
Si trattava perlopiù di gruppi di popolazione emarginata e malvista dai francesi, assimilata ai più poveri dei colonizzati tunisini. Tuttavia, riprendendo i modelli interpretativi proposti da Turchetta (2018: 83) a proposito della migrazione italiana nella regione canadese dell’Ontario, la numerosità e la comune origine di questi migranti (spesso provenienti dallo stesso paese della Sicilia o da paesi tra loro confinanti) determinarono “dinamiche di aggregazione e di solidarietà sociale” tali da consentire alle varietà regionali (e dialettali) di matrice italiana di conservarsi e di essere trasmesse in qualche modo, come avrò modo di dire, alle seconde generazioni.
L’esistenza di questa eterogenea e consistente componente italiana nel tessuto sociale tunisino finì per essere stravolta nel periodo del fascismo e della seconda guerra: nel 1944, infatti, le autorità francesi, con un’operazione che puntava a indebolire la componente italiana del Paese, chiusero scuole, associazioni culturali, redazioni di giornali (espellendo molti intellettuali), sostituirono i vertici della dirigenza dell’ospedale italiano “Giseppe Garibaldi” ed estesero l’obbligo di cittadinanza francese agli stranieri nati in Tunisia da almeno un genitore di origine straniera ma nato in Tunisia, già avviato dal 194010. Più tardi, con la raggiunta indipendenza della Tunisia dal protettorato francese (1956), la volontà del governo di Habib Bourguiba fu di assegnare precedenza occupazionale ai tunisini, a discapito degli stranieri. Fu così messa in atto una serie di restrizioni tale da portare molti italiani a perdere il lavoro, determinando la modifica del progetto migratorio: intere famiglie scelsero l’esodo volontario, o verso l’Italia o verso la Francia11 (avviando così una nuova diversa emigrazione).
2. Il recupero della memoria, il contesto nel quale si sono svolte le inchieste linguistiche e il corpus oggetto di analisi
Una delle evidenze più ineludibili emersa in occasione delle mie campagne di rilevamento è che, da diversi decenni ormai, tra i discendenti degli italiani – sia quelli ancora residenti nel Paese sia quelli esodati tra Italia e Francia – si è affermato il bisogno di recuperare la memoria storica dell’“avventura italiana” in Tunisia. Basti pensare all’opera fondamentale e instancabile della scrittrice italotunisina Marinette Pendola, sia attraverso i saggi espressamente dedicati al tema (1999, 2000a, 2000b), sia attraverso i propri romanzi memorialistico-autobiografici (2000d e 2014)12. A tali romanzi, si aggiunge poi tutta una svariata produzione di racconti e memoriali generati dalla stessa urgenza di raccontarsi e raccontare, recuperando la memoria storica di eventi poco noti e ormai quasi del tutto obliati13. Ma non si può dimenticare neppure il grandioso “progetto della memoria” degli italiani di Tunisia avviato nel 2000 dall’italotunisina Silvia Finzi14, con il coinvolgimento di ricercatori e studiosi di varia provenienza, chiamati a
interessarsi ai rapporti tra Italia e Tunisia ed anche a quelli dell’Italia con il mondo arabo in generale, poiché la qualità della vita degli italiani ne è spesso conseguenza, ai rapporti della collettività con lo Stato italiano e con lo Stato tunisino e reciprocamente, ai luoghi storici del loro insediamento, ai diversi usi e costumi che portarono con sé dall’Itala, ed alle modifiche, evoluzioni ed interazioni che questi subirono nel confronto con una realtà diversa, alle loro feste, ai loro linguaggi, alle diverse istituzioni che crearono, ai loro credo politico e religioso, all’impatto […] nella costruzione della Tunisia moderna… (Finzi 2000: 5).
È inoltre il caso di ricordare la creazione ad opera di Alfonso Campisi, nel 2016, della cattedra “Sicilia per il dialogo di culture e civiltà Vincenzo Consolo”, nell’Università della Manouba, in seno alla quale il professore italotunisino punta a rinnovare attivamente il rapporto tra la Tunisia e la Sicilia, anche attraverso lo studio del patrimonio linguistico e culturale dell’isola, innegabilmente contrassegnato al suo interno da eredità arabo-berbere, in relazione alla dominazione musulmana dei secoli IX-XI. Allo stesso Campisi e a Flaviano Pisanelli (Università di Montpellier) si deve anche la raccolta di Memorie e racconti del Mediterraneo. L’emigrazione siciliana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo (2015)15.
Infine, merita di essere menzionata la realizzazione di una serie di corto e lungometraggi variamente prodotti negli ultimi decenni con l’obiettivo di preservare dall’oblio la storia degli italiani di Tunisia, facendola raccontare il più delle volte ai diretti interessati, ben contenti di restituire dignità storica alle vicende delle proprie famiglie16.
È in tale clima, così densamente intriso del bisogno di raccontarsi e di far conoscere una storia perlopiù dimenticata, che ho condotto le mie inchieste, trovando un grande spirito di collaborazione e un’accoglienza che difficilmente riuscirò a dimenticare. Grazie alla generosità del regista Marcello Bivona, ho potuto servirmi delle videoregistrazioni da lui realizzate per il lungometraggio Siciliani d’Africa. Tunisia Terra promessa17: alcuni dei dati qui discussi derivano da tali materiali (che d’ora in poi indicherò come Corpus B). E poi, grazie al supporto dei colleghi Alfonso Campisi e Silvia Finzi, “testimoni privilegiati” del fenomeno studiato, ho potuto condurre tanta parte delle osservazioni dirette di cui mi sono servita per le mie ricerche e ho anche potuto conoscere, fra gli altri, Rita Mangogna, presidente della casa di riposo le Foyer familial “Delarue-Langlois” dove, già in occasione di uno dei miei primi viaggi a Tunisi, nell’ottobre del 2018, ho incontrato molte italiane e italiani. Determinante è stato poi il passaparola (anche attraverso Facebook): grazie ad esso, tra luglio e agosto del 2022, in circa tre settimane, mi è stato possibile intervistare ben 25 persone. Ma più ancora delle singole interviste, è stata l’osservazione partecipante, favorita dall’affettuosa ospitalità degli intervistati e dal loro approccio amicale, a determinare l’importanza degli incontri per il progetto in sé, per i dati linguistici emersi e per la ricostruzione del repertorio (i materiali così raccolti costituiscono quello che d’ora in poi indicherò come Corpus V).
3. Dati socio-biografici del campione e metodologia della ricerca
Le riflessioni contenute nei paragrafi che seguono si basano sulle produzioni orali di 14 Heritage Speakers (riferibili al corpus B e V). Si è scelto di soffermare l’attenzione in particolare su 9 parlanti di II generazione (sei donne e tre uomini, di età superiore ai 75 anni) e su 5 parlanti di III generazione (quattro donne e un uomo, di età inferiore ai 75 anni)18. Si tratta di persone nate in Tunisia, tutte capaci di parlare in francese (oltre che in arabo tunisino19) e di padroneggiare in vario modo anche l’italiano, nella maggior parte dei casi appreso però solo in famiglia, spesso parallelamente al dialetto, dal momento che in Tunisia, dopo la seconda guerra mondiale, la scolarizzazione primaria in italiano venne interdetta a favore dell’esclusiva scolarizzazione in francese.
Nella tabella che segue, ad ogni persona è assegnata una sigla di riconoscimento, seguita nell’ordine da: a) anno di nascita, b) età anagrafica, c) genere, d) livello di istruzione, e) attività occupazionale, f) luogo di residenza, g) luogo di provenienza e h) corpus di riferimento. Si tratta di italotunisini residenti nell’area metropolitana di Tunisi. Tutti vivono (e hanno vissuto in Tunisia) da almeno tre generazioni (a non voler considerare, per alcune famiglie, esperienze migratorie precedenti di singoli rami, ad es. quello di uno dei nonni materni o paterni).
|
Sigla del parlante |
Nascita |
Età |
Genere |
Istruzione |
Occupazione |
Residenza |
Provenienza della famiglia d’origine |
Corpus |
|
CS |
1935 |
87 |
F |
E |
casalinga |
Tunisi (Mutuelleville) |
Marsala |
V |
|
CT |
1935 |
87 |
F |
S |
insegnante |
Tunisi (La Marsa) |
Marsala |
V |
|
ACa |
1937 |
85 |
M |
S |
imprenditore |
Tunisi (Mutuelleville) |
S. Giuseppe Jato/Trapani |
V |
|
MAB |
1937 |
85 |
F |
E |
casalinga |
Tunisi (Rades) |
Comiso/Palermo |
V |
|
JG |
1940 |
82 |
F |
E |
casalinga |
Tunisi (Rades) |
Palermo |
V |
|
GT |
1942 |
80 |
M |
E |
imprenditore |
Tunisi (La Marsa) |
Corleone/Favignana |
B/V |
|
PM |
1942 |
80 |
M |
E |
imprenditore |
Tunisi |
Trapani |
B |
|
MR |
1946 |
76 |
F |
L |
funzionaria |
Tunisi (La Marsa) |
Palermo/Trapani |
V |
|
RS |
1946 |
76 |
F |
S |
funzionaria |
Tunisi (Mutuelleville) |
Marsala |
V |
|
JR |
1947 |
75 |
F |
E |
casalinga |
Tunisi (Rades) |
Palermo |
V |
|
MJT |
1947 |
75 |
F |
S |
funzionaria |
Tunisi (La Marsa) |
Marsala |
V |
|
RZ |
1948 |
74 |
F |
E |
casalinga |
Tunisi (Oued Ellil) |
Mogoro (Sardegna)/Paceco |
V |
|
RM |
1952 |
70 |
F |
S |
casalinga |
Tunisi (La Marsa) |
Castelvetrano |
V |
|
ACo |
1955 |
67 |
M |
S |
libero profess. |
Tunisi (La Marsa) |
Palermo/Favignana |
V |
Tab. 1 – Il campione
I dati sono stati vagliati tenendo conto dei modelli interpretativi dell’emigrazione italiana definiti da Turchetta, Vedovelli (2018) e Vedovelli (2011, 2020, 2021) (per citarne alcuni), oltre che degli strumenti messi a punto dalla letteratura relativa alla variazione linguistica, al mutamento linguistico (anche in riferimento ai fattori di linguistica esterna, legati a età anagrafica, e quindi generazione, sesso, livello di istruzione e contesto di produzione)20. Nel trascrivere il parlato, ho cercato di evidenziare particolarmente i tratti fonologici peculiari, servendomi di alcuni simboli speciali (in parte tratti da Trovato, Menza 2020 e in parte dal V volume del VS): <ë> per la vocale anteriore semichiusa /e̝/ (es.: it. pésca); <ö> per la vocale posteriore semichiusa /o̝/ (es.: it. dóno); <ç> per la fricativa palatale sorda /ʃ/ in posizione intervocalica; <ṡ> per la fricativa alveolare sonora /z/ intervocalica (es.: toscano peçe ); <ż> per l’affricata dentale sonora /dz/ (es.: it. zaino); <ḍ>/<ḍḍ> per l’occlusiva alveolare /ɖ/ e /ɖɖ/ (es.: siciliano cavaḍḍu ‘cavallo’); <ṭṛ> per l’affricata prepalatale sorda (ad es. nell’italiano regionale ṭṛapanese)21.
4. La ristrutturazione del repertorio linguistico originario tra italianizzazione e francesizzazione: le testimonianze dei parlanti
La lingua nella quale ho potuto condurre le interviste è stata, quasi sempre, l’italiano; solo due donne mi hanno risposto in francese, pur comprendendo perfettamente l’italiano (CT e JG) e in due (oltre a CT, anche CS) hanno dichiarato di non conoscere l’arabo (o di conoscerne appena qualche elemento di poco conto). Tutti gli intervistati e le intervistate hanno frequentato la scuola francese (dove qualcuno ha appreso l’italiano come L2), ma le informazioni raccolte rinviano comunque all’imponente processo di italianizzazione cui parteciparono i genitori degli intervistati (figli e talvolta nipoti dei primi emigrati), frequentando inizialmente le scuole italiane presenti in Tunisia, fortemente volute dai gruppi italiani di prestigio e certamente favorite dal nascente Stato italiano.
L’italiano e la varietà di siciliano dominante si sono mantenuti fino ad oggi, pur se ridotti ormai – nella comunicazione quotidiana – ad usi perlopiù familiari e amicali: l’impiego del siciliano è regredito insieme al regredire del prestigio dei parlanti in seno alla società tunisina.
Dati simili emergono anche, per gli italiani di origine toscana, dalle interviste a italo-tunisini (di origine giudaica) effettuate da Orfano (2014), come si vede dagli esempi di seguito riportati:
[…] Noi parlavamo bagìto22, a casa. Tant’è vero, veda un po’ ehm mi ricordo trenta quaranta espressioni […] non era una lingua veramente segreta, ma almeno era la lingua per riconoscersi […]. E poi anche una lingua di di piacere, la famiglia si era in famiglia […]. Nel nostro italiano erano inserite parole di bagìto […] il mio italiano è cambiato anche, la mia pronunzia da bambino è cambiata, perché col tempo son ho studiato l’italiano a scuola […]. Ho studiato sette anni l’italiano a scuola. (Giacomo Nunez, giudeo-italiano nato dopo il 1923: Orfano 2014: 133, corsivo mio)
[l’italiano] l’ho imparato a scuola, poi in famiglia, l’ho imparato in famiglia […]. A casa di mio padre parlavamo francese, ma da mio nonno, quando eravamo in famiglia parlavamo soltanto in italiano […] miei cugini hanno fatto gli studi a la all’asilo italiano poi alla scuola italiana, invece io l’ho fatto alla scuola francese perché la mia madre era francese […]. [Con i clienti arabomusulmani] parlavamo un po’ l’arabo per farci capire e con quelli che parlavano francese francese […]. Talvolta in una frase eeh parole italiane mescolate con le paro… parole arabe o pa… parole tunisine o le parole eeh francesi ma non mi ricordo proprio [sic] d’un, che ci sia stato un una lingua speciale, una un dialetto speciale […] (Adolfo Disegni, giudeo-italiano, nato nel 1926: Orfano 2014: 138,cursivo mio)
Quale che fosse la lingua usata nell’intimità familiare – il bagito nel caso degli ebrei livornesi o il siciliano per gli italiani provenienti dalla Sicilia – gli intervistati, in qualità di emigrati di seconda e terza generazione, riferiscono il progressivo transito dall’italiano dei loro nonni e/o genitori alla lingua di maggior prestigio – in questo caso il francese – fino a una condizione prevalente di bilinguismo italiano/francese, quando non di trilinguismo italiano/francese/tunisino. È chiaro però che la varietà di italiano cui si fa riferimento è oggi ormai una L2 e, sul piano della competenza comunicativa, per i più giovani forse anche una L323.
In generale, per i discendenti dell’emigrazione postunitaria, il siciliano (un tempo lingua prevalente all’interno delle comunità emigrate) rimane comunque sullo sfondo ed è innegabile che se ne abbia ancora oggi reminiscenza: si trattava tuttavia di un codice già fortemente stigmatizzato nell’ambito familiare, particolarmente dalle madri che – siamo ancora nella prima metà del Novecento – avvertivano l’urgenza di orientare i figli verso la lingua nazionale dell’Italia, rivendicando in tal modo un’appartenenza identitaria forte e, al contempo, la volontà di non recidere i rapporti con la madrepatria. Per questo, gli intervistati e le intervistate riferiscono spesso l’uso prevalente dell’italiano in famiglia, anche quando in realtà, il dialetto continuava ad essere tramandato, specialmente dai nonni e dalle nonne, finendo inevitabilmente per marcare come regionale l’italiano utilizzato, tanto più in assenza di una norma di riferimento (venuto meno l’insegnamento scolare).
Si leggano ad es. le parole di ACa (classe 1937, livello di istruzione superiore, intervista del 18 agosto 2022), quelle di RM (classe 1950, livello di istruzione elementare), di RS (classe 1947, livello di istruzione superiore) e di ACo (classe 1955, livello di istruzione superiore, intervista del 27 luglio 2022). Il primo sottolinea come a casa si parlasse tendenzialmente in italiano, mentre per lui la lingua della scolarizzazione è stata il francese:
A.C. – Mamma parlava sëmpre in italiano.
I.V. – Quindi lei ha imparato l’italiano dalla mamma…
A.C. – Dalla mamma, dal papà, dalla nönna, dai nönni.
I.V. – Quindi in famiglia si parlava in italiano.
A.C. – A-ccaṡa sempre in italiano.
I.V. – Mentre quando lei è andato a scuola la lingua dell’istruzione…
A.C. – …il francëṡe. Infatti, perché i nöstri figli söno partiti in Francia?: perché anche löro hanno studiato in francëṡe, automaticamente son partiti per prendere un diplöma e-ssöno rimasti lì.
Salvo poi affermare:
A.C. – [Il dialetto] lo parlo con mio fratëllo, ogni tanto. Qualche, qualche amico, ancöra ci’ho qualche amico siculo-italiano che qualche volta ci… una piccola conversazione in siçiliano. Ṭṛapanëṡe, ah!, perché io sono stato cresciuto da mia nönna e ho imparato il dialetto ṭṛapanëṡe, che è molto più dolce del palermitano.
[…]
I.V. – Gli altri riconoscono che lei è italiano?
A.C. – M’hanno spësso dëtto che ëro siçiliano, che avevo l’accento siçiliano. Io non me ne accörgo, ma löro se ne söno accörti.
[…]
I.V. – Con i suoi genitori parlavate in italiano?
A.C. – Sempre in italiano. Anzi, quando parlavamo siçiliano, mamma diçeva «parla italiano!».
Impossibile non notare, in tali stralci, l’innalzamento delle vocali medie (söno, ṭṛapanëṡe, löro ecc.), la pronuncia fricativa dell’affricata sorda intervocalica (ad es. in siçiliano) e l’affricata prepalatale sorda lene (ad es. in ṭṛapanëṡe), tutti tratti riconducibili ad una fonologia di matrice siciliana (nel caso delle vocali, di area occidentale), certo non dell’italiano.
Come ACa,, anche RM (classe 1951, livello di istruzione elementare, intervista del settembre 2022) dichiara che i propri genitori le «parlavano sölo in italiano». Lo stesso testimonia RS (classe 1947, livello di istruzione superiore, intervista del 20 luglio 2022) quando dice:
– Mia madre mi parlava in italiano. Ai bambini piccoli non si parlava il siçiliano… Era… […] Il siçiliano lo capivo bëne perché i miei genitöri parlavano tra di löro in siçiliano. E-ttutte le völte che mi azzardavo, mia madre mi diçeva: ah?, c’hai dëtto? Quindi io söno stata autorizzata a-pparlare in siçiliano abbastanza grandina, tipo verso növe/dieçi anni.
Il suo italiano, sicuramente di livello alto, è chiaramente interferito sia dal francese (per la presenza, documentata da altri stralci, delle fricative dentali sonore intervocaliche), sia dal siciliano, per la solita pronuncia fricativa delle affricate palatali sorde (diçeva, siçiliano, dieçi) e, particolarmente, per l’innalzamento delle vocali medie e l’intonazione dell’eloquio, spiccatamente marcati, sul piano percettivo, in direzione del siciliano occidentale. Il dialetto, quando affiora, viene usato in enunciati di carattere emozionale, ormai fossilizzato come lingua della memoria.
E ACo non manca di ricordare (nel suo caso, la padronanza dell’italiano si accompagna a quella del francese e dell’arabo):
ACo – Mamma mi parlava in francëṡe, papà mi parlava in siçiliano e io rispondëvo in francëṡe.
I.V. – Dunque nella tua dimensione familiare le lingue che circolavano erano il francese e il siciliano…
ACo – Francëṡe, dialetto siçiliano e l’italiano parlato da mamma in risposta al siçiliano di papà.
I.V. – Perché, la mamma non sapeva parlare in siciliano?
ACo – Non lo so se non sapëva, però non parlava in siçiliano.
I.V. – Preferiva rispondere a papà in…[
ACo – Non so se preferiva, penso che sia, era spontaneo, non era, non era, crëdo che sia… che ërano delle risposte premeditate, calcolate, no, no.
ACo -Papà era [parlava in siciliano]
I.V. – Ma aveva imparato anche altre lingue…?
ACo -Sì, papà parlava l’italiano.
La conservazione del dialetto nelle famiglie emigrate non impedì che esse partecipassero all’imponente processo di italianizzazione avviato dopo l’Unità d’Italia anche nei Paesi d’emigrazione e, più tardi, dopo la seconda guerra mondiale, di approdare comunque al francese, divenuto ormai lingua esclusiva della scolarizzazione primaria.
L’estensione dell’obbligo di cittadinanza francese è ricordata da molti degli intervistati. Ad es. ACa ricorda: «Io sono nato nel ’37, nel 39 c’è stata la guerra, dunque, due anni… e sono ritornato a scuola all’età di otto anni, e alla scuola francese, perché non c’erano più le scuole italiane. E io l’italiano non l’ho mai studiato […]». Dal canto suo, ACo (classe 1955, intervista del 27 luglio 2022) racconta:
– Nönno [paterno] vënne in Tunisia negli anni Trënta, nel periodo fascista, periodo mölto delicato per l’Italia economicamente, e vënne con due fratëlli, i suoi due fratëlli, per mëttere su un laboratörio di ebanisteria. Il nönno matërno lavorava in una ditta importante francëṡe […] e gli chieṡero a un momento, a un certo punto gli chiëṡero di prendere la cittadinanza francëṡe, si non… lo buttavano fuöri. Accettò ovviamente, aveva dei figli. Dunque mamma divënne francëṡe anche lei. Da lì le mie due cittadinanze.
Le mutate condizioni storiche e la necessità che alcuni italiani (siciliani) prendessero in considerazione di cambiare nazionalità e francesizzarsi pur di mantenere le proprie attività lavorative, assicurando così il benessere alle proprie famiglie, ebbero non poche conseguenze anche sulla convivenza tra gli stessi italiani (siciliani), persino nei rapporti tra componenti dello stesso nucleo familiare, come testimonia ad es. il racconto di GT (classe 1942, livello di istruzione elementare, intervista del 27 luglio 2022):
– Uno dei żii, uno dei figli di mio nönno che aveva una fonderia, grössa fonderia, lavorava per i francëṡi, perché c’era u…, qui a Biṡerta, loro avevano una baṡe militare, grande (non so se lo sa, i francëṡi avevano una baṡe militare mölto importante, tanto è vero che ancöra öggi, ad öggi, questa baṡe militare, di marina, è sotto ancora… sotto la…., l’emprise, come si può dire, sotto la… il dominio degli americani e dei francëṡi, ancöra, sì, sì, perché è una ba…/ perché è un passag…/ c’est une base strategique, c’est un passage, la… la Ferryville, Ferryville de Biserte […] existe encore […]). La fonderia era a Tuniṡi e mio zio, mio padre che era un piccolo trasportatöre, aveva un paio di camion lancia […] e lavorava con il fratëllo di mia madre, cioè col cognato, e trasportava queste cöse, queste pëzze di fonderia alla base militare francëṡe. Mio nonno un giorno lo venne a sapëre, che, mio zio, per poter mantenëre questo rappörto di lavöro con la base militare francëṡe ebbe dovuto, dovè… cambiare nazionalità, divënne francëṡe. E un giörno arrivando a-ccaṡa (perché mio nönno… veniva, mio żio Domenico, si chiamava Domenico, veniva a trovare suo padre a-ccaṡa nostra, mio nönno vivëva con nöi, è sempre vissuto con nöi), è entrato a-ccaṡa e gli disse… gli baçiava la mano, Vossìa (gli davano del “lei”, del “vöi”, a mio nönno, mia madre a suo padre dava del “voi”: era un’uṡanza anche siçiliana, lo sappiamo tutti) e gli baçiava la mano. «Leva sta mano, lèvati sta manu, ppuh!», e gli sputava in faccia, sììì, «Carni vinnuta! Tu si na carni vinnuta, tu cca nun ci’ha vèniri chjui, nni sta casa ccà, capisti, vattinni!». Ma, ci fu uno scambio di cose, terribile, guardi ho la pelle d’öca, ho la pelle d’öca! E mio żio con le lacr…, quaṡi lacrimando, «Ma papà… sono stato obliga…», «Vattinni, nun ti vöghju vìriri ccà, vattinni». Mio nönno piangëva quaṡi, dalla rabbia che quësto figlio avësse tradito la nöstra störia, tradisse la nöstra… [si rivolge a un amico presente] Tu comprend? C’ètait fort! Tu te mêle aux Français qui nous ont enlevé les terres. Mio nönno avëva un piccolo, una piccola coṡa viçino Tuniṡi, un ettaro soltanto, di mandorle. Ce lo tölsero anche a nöi.
Anche MR (classe 1946, livello di istruzione superiore, intervista del 21 luglio 2022) racconta – con il suo italiano colto (anche in ragione della precedente attività lavorativa in seno al consolato italiano), fortemente interferito dal francese – della resistenza del padre rispetto alla naturalizzazione francese:
– Al momento in cui dovevamo inserirçi nel sistema scolastico ovviamente, nel Cinquantadue dovevamo essere iscritte alla prima elementare, le scuole francëṡi c’erano (quelle italiane ormai erano out da quando e lo sai meglio di me), papà – italiano nell’animo, italiano nello spirito, italiano nel cuöre, nel sangue e tutto quello che può essere – dispiacëva di nön poterci inserire nell’insegnamento italiano, per cui, vabbè, diçe pazienza quësta è la realtà, però, però… nel momento in cui, cioè in cui hanno effettuato i docume…, insomma quel che è l’iter per l’iscrizione alle scuöle francëṡi, ecco là che l’amministraziöne francëṡe diçe «ma le sue bambine…[…] perché non söno francëṡi?» «Perché non ho nessuna intenziöne di scëgliere o di optare per la nazionalità (francese)».
La frattura tra siciliani che si naturalizzarono come francesi e siciliani che rimasero pervicacemente attaccati alla cittadinanza italiana fu dolorosa quanto, in molti casi, inevitabile. Non a caso, al riguardo, nel docufilm Siciliani d’Africa. Tunisia terra promessa, il siculotunisino PM (classe 1942), oscillando tra francese e italiano e lasciando al dialetto uno spazio residuale limitato a formule ormai cristallizzate, dichiara:
– Il y avait un moment ou les siciliens avaient un complexe énorme vis-à-vis des français… français et italiens s’en allaient pas très bien ici, pour le français les italiens c’étaient zibbola, c’étaient rien du tout, c’étaient les pauvres… et quand de la corporation, de li ambienti dei siciliani, quando qualcuno voleva diventare francëṡe, mamma miaːːːːː ! carni vinnuta ! saccu svotatu ! Tous les enjeux du monde ! Et quand mon père il se fait français en 1949, tous le siciliens l’ont fermé la porte !
A quel punto, le sorti del repertorio erano ormai segnate: l’italiano con le sue varietà si avviava ad avere un ruolo relegato ai contesti d’uso familiari o amicali, sia pure sempre in situazioni di mistilinguismo, come è apparso evidente per tutti i parlanti interpellati e anche per i protagonisti dei docufilm.
E tuttavia, durante il boom economico, nulla impedì agli italiani di continuare a praticare l’italiano grazie ai mezzi di comunicazione di massa, primo fra tutti la televisione. Appare chiaro, ad es., da quanto dichiarato da CT (1935, livello di istruzione superiore, intervista del 21 luglio 2022) la quale, dopo aver confessato la propria incapacità di parlare in italiano, precisa comunque con forza di essere italiana, di capire tutto e di continuare a seguire i programmi televisivi solo in italiano:
I.V. – Dans quelle langue ou dialecte avez-vous appris à parler ?
CT – Je, J’ai appris à parler en français, toujours !
I.V. – La maman avec vous parlait en français ?
CT – En français ! Et mon père aussi, parlait en français. Et l’ècole des sœurs aussi, bien sûr, en français !
[…]
– Si vous voulez bien comprendre, je suis restée italienne !
Je parle pas italien, je sais pas. Je vous comprende très bien, parce que j’ai toujours parlé français, à l’école, avec mon marie, avec mes parents, français ! Mais, j’ai des abitudes italiennes ! […] Je regarde la télé italienne. Le matin je me lève, j’allume RAI Uno, Je continue pour le reste !
La donna si riconosce una competenza comunicativa dell’italiano talmente bassa da non sentirsi in grado di affrontare una conversazione interamente in italiano. Ciò malgrado, essa rimane fortemente ancorata alla lingua italiana (e comunque quella di seguire i programmi televisivi in lingua italiana è quasi una necessità, dichiarata particolarmente dal gruppo degli intervistati di età superiore ai 75 anni). Diversamente, la sorella, MJT (classe 1947, livello di istruzione superiore) ha sempre continuato a parlare, oltre che in francese, anche in italiano (per ragioni professionali): l’intervista e l’osservazione partecipante consentono di evidenziare che il contatto costante con il francese ha condizionato sensibilmente il suo italiano, soprattutto sul piano fonetico.
In generale, tutti gli heritage speakers incontrati, negli scambi comunicativi conservano la capacità non solo di comprendere l’italiano ma anche di parlarlo (come hanno mostrato quasi tutti durante le interviste e anche nell’osservazione diretta), sebbene ormai la lingua prevalente della comunicazione quotidiana sia il francese, a volte in alternanza con l’arabo (ma questo più per gli uomini – proiettati verso l’esterno dagli impegni lavorativi – che per le donne). La stessa CT, di professione maestra, dichiara di aver sempre parlato in francese, e di averlo fatto anche con gli stessi bambini tunisini ai quali doveva insegnare il francese.
L’importanza riconosciuta all’italiano, prima, e al francese, poi, non ha cancellato l’uso del dialetto che si è mantenuto, carsicamente, nel repertorio degli italotunisini, pur con diverso impiego funzionale (anche in relazione al livello di istruzione e alle attività lavorative) rispetto alle lingue di prestigio e rispetto allo stesso arabo tunisino, lingua della comunicazione con la popolazione locale. Lo usano, ad es., sia pure insieme al francese (dominante), RS e CS, come emerge nel corso dell’intervista. Il livello di scolarizzazione (in francese) che le due sorelle possiedono è tale da consentire loro di tenere distinte la competenza del francese e quella dell’italiano, lingua appresa oltre che in contesto familiare anche alla scuola francese, come materia di apprendimento L2. Entrambe dichiarano di parlare tra loro in siciliano, ma il dato non è emerso nel corso dell’intervista, prevalendo il ricorso ad una varietà, l’italiano, avvertita come più prestigiosa.
Analogamente, JR (classe 1947, livello di istruzione elementare, intervista dell’ottobre 2018) riferisce un uso esclusivo del dialetto quando conversa con la sorella, ma tale competenza dichiarata affiora appena durante l’intervista: il prestigio da sempre riconosciuto all’italiano impedisce infatti alla signora di esprimersi liberamente in siciliano (il dialetto rimane la lingua della comunicazione intima, familiare) e piuttosto emerge lo sforzo di utilizzare l’italiano, pure se, a differenza dei casi precedenti, si tratta di un italiano malfermo e fortemente interferito dal francese e dal siciliano (sia sul piano fonologico sia sul piano sintattico), come si può osservare nello stralcio di seguito riportato:
I.V. – Bonjour! Bonjour madame!
JR – Bonjour!, Buongiorno, buonasëra, come vuöle…
I.V. – Buonasera! Ah, allora voi parlate in italiano!
JR – So/ söno italiana! Sì, söno italiana!
I.V. – Come sta?
JR – Coṡì coṡì, non tanto bene…
I.V. – No ːːː, [mi dispiace!
JR – [Non tanto bene. Questa non è la mia camera, sono in f[
I.V. – ((è ospite in questo momento))
JR – Söno en face, je suis, nfacci di lei, voilà
I.V. – Sì, sì
JR – E lei viene dal consolato?
I.V. – No, vengo dalla Sicilia…
JR – Ah, in Sicilia, io sön d’origine siciliana [sorride]
I.V. – Ah sì? Di dov’è?
JR – Palerme, di Palermo.
I.V. – È nata qui? Oppure…
JR – Sì, nata qui, nata in Tuniṡia.
I.V. – Ha studiato l’italiano a scuola?
JR -No, no, non ho studiato l’italiano, non c’era scuola italiane.
I.V.- Eh, ma lo parla bene! [Brava…
JR – [C’era scuola n francëṡe, la scuola francëṡe.
I.V. – Però lei parla l’italiano bene.
JR -Sì va bene, lo parlo mmm, förse… il siçiliano lo parlo bene.
I.V. – Ah, pirchì non mi parla in siciliano ? Scusassi!
JR – [sorride] Mi viene un po’ diffiçile!
I.V. – E picchì?
JR -E picchì ? ((ride))
I.V. – Lei m’ha dittu ca parrava n sicilianu, no?
JR -In siçilianu… [chi cci capemu!
I.V. – [nni capemu megliu, no?
JR – Cchi ci capemu?… Mio padre diçeva: “cataniṡi, hai unu ogni paiṡi, s’un ci fussi, megghjiu fussi”
[…] No, io con mia sorëlla non parliamo mai in italiano, parliamo in siçiliano.
I.V. – Eh! In sicilianu !|
JR -Ma com’è che c’è la televiṡiöne italiana, là, e coṡì uno si… Si impara… si no, bon, lo capisco tutto l’italiano, ci sön paröle a völte che non trövo facilmente […] mi pare strano che dëvo parlare siçiliano con una che viëne d’in Italia!
Ci sono volte, poi, nelle quali il repertorio è ancora più complesso (al di là del livello di istruzione).
Penso a casi come quello di RZ (classe 1948, casalinga, vedova, livello di istruzione elementare; in Tunisia arrivarono per primi i nonni): dopo aver sposato all’età di 17 anni un siciliano ed essersi trasferita a Oued Ellil (oggi popoloso sobborgo a nord-est di Tunisi, ma un tempo insediamento agricolo dove risiedevano molti siciliani), la signora ha sostituito al proprio dialetto, il sardo, la lingua del marito, mantenendola fino ad oggi come L2 (accanto all’italiano, appreso grazie alla televisione e al contatto con i parenti italiani e dopo il francese L1, al punto da aver promosso l’apprendimento dell’italiano – e di un po’ di siciliano insieme – da parte delle nipotine).
RZ – […] mio papà è nato a Sfax, perché c’era là una miniera di piombo, no? Eːːːh, e quelli rimpatriati di là, della Sardegna, della Siçilia, andavano tutti nelle miniëre a lavorare e i miei nonni hanno lavorato nelle miniëre di piombo. Dopo andò… sempre cambiavano, cambiavano di paeṡe. Poi söno arrivati alla miniera di / döpo Mateur […], e hanno lavorato lì per vent’anni, nella miniëra. E siamo nati lì […], a Béja […] siamo cresciuti lì, finaːːː/ io fin’all’età di quartodicianni, poi siamo stati rimpatriati in Italia. […] A diçiötto anni mi söno sposata […] siamo venuti qua per passare quindiçi giörni, invece ci siamo passati qua çinquant’anni! […]
IV – Che scuola ha fatto?
SB – Sixième ((si rivolge al figlio)) – Sixième cos’è? Ti parlo: – Sixième, a sixième élémentaire […] in francëṡe, sì, eh sì, parle franceṡe. […] mia mamma era siçiliana e-pparlava con mio papà in sardo, e-pparlavamo tutti in sardo! […] Bon, Parlava sːːː, siçiliano, non se l’è-ddimenticato, però parlava sardo puru cön mio papà. […]. Lei non l’ha dimenticato il siçiliano, perché, lì, alla mina dov’eravamo, a Béja, c’erano tanti siçiliani che lavoravano là e-pparlava con löro, non l’ha-ddimenticato. Però a-ccaṡa parlavamo sardo, a scuola francëṡe, c’era solo il francëṡe. Döpo, quando siamo andati via, nel ‘62, hanno messo le scuoli arabe e noi l’arabo non l’abbiamo mparato a leggere e a scrivere, tandis que loro ((si rivolge al figlio)) l’hanno imparato/ che hanno fatto le scuole francëṡi e arabe.
Nel complesso, l’italiano di RZ esibisce una serie di fenomeni di interferenza del siciliano a più livelli24. Il sardo sembra scomparso (a parte qualche traccia nella prosodia), mentre risalta sul piano fonologico segmentale la chiusura delle vocali toniche medie (affine a quella dei siciliani di area occidentale). Il francese affiora in commutazioni intrafrasali (Sixième élémentaire ‘sesta elementare’; tandis que locuz. cong. ‘al contrario’ (avversativa), parzialmente ripetuta poco oltre (tandis que loro […] l’hanno imparato/ che hanno fatto le scuole francesi e arabe) o extrafrasali (con il segnale discorsivo bon ‘bene’); e non manca commutazione interfrasale, all’interno di un’epanalessi (francese, sì, eh sì, parle franceṡe ‘francese sì, eh, io parlo francese’).
È il rimando a quella «fluttuazione che ciascun parlante, in relazione agli eventuali percorsi migratori, alla fluidità delle valutazioni personali sul valore delle lingue di propria competenza e secondo il contesto di uso opera» (Turchetta 2028: 88). Così, quando GT si racconta nel docufilm, la lingua che sceglie di usare non è più l’italiano, come nell’intervista (avvertita sicuramente come più formale e soggetta al continuo code switching in relazione alla presenza di altri parlanti, italotunisini ed ebreotunisini), ma un siciliano fortemente interferito dall’italiano, condiviso dagli altri italotunisini presenti sulla scena:
– Unn-eravamu pöcu, eravamu 130.000 dei siçiliani ccà, eh! Quaṡi tutti siçiliani dal sud della Sicilia, dâ parti dâ Tuniṡia. Eranu tutti piscatöri, ëranu tutti agricoltöri, um-bìnniru ccà i siciliani… i granni siciliani, scrittöri, poeti, vìnniru ccà tutti chiḍḍi… cc’era n pöcu di miṡëria, vìnniru ccà a-ccircari lavöru, a-ccircari um pezzu di pani… eh, cuminciàr(u)n(u) (ac)cussì. […]
La mia famiglia è ffatta di… di due… di due provenienze: dâ parti di ma matri èranu di Favignana, da parti di me patri èranu di Corleön(i). […]
Arrivammu ccà, si mìṡeru a lavurari eh, c’eraːːː… c’era fami, c’era da lavurari subbito, da fari i cöṡi i ppiù… ppiù/ i cöṡi… i cchjiu façili da fare, quindi ncominciàru a lavurari ccâ pisca, ncominciàru a lavorari nnâ terra e e tutta sta ggenti ccà ca nun avëa un mestjëre u fìciru chjanu chjanu, diventàrunu speçialisti, diventàrunu meccàniçi, lettriçisti, addivintàrunu… tutta gente che poi si formò, si formò ccà, picchì eranu tutti giuvini, quannu arrivaru ccà un sapìvunu fari nenti.
Diverso è il caso, ad es., di MAB (corpus V), casalinga, vedova, vissuta sempre a Tunisi (dove si stabilirono, prima di lei, i suoi genitori), che ha studiato italiano (insieme al padre), in uno dei corsi promossi dalla Dante Alighieri, ma che a casa usava solo il siciliano (e quello che lei chiama “italiano”). La sua produzione, infatti, è in italiano ma tradisce inequivocabilmente l’interferenza del dialetto, configurandosi come varietà di italiano popolare. Le caratteristiche del suo italiano, ancora resiliente, si possono associare alla recenziorità del progetto migratorio della sua famiglia:
– Mio padre era del Comiso […] Ho avuto l’occasiöne di avëre un bellu pösto / standardista ah / Standard dei telefoni,/ standard / ma/ ho av/ ssss / si era ora può darsi che avëvo continuato a/ a lavorare, ma ero troppo timida ero, mi hanno fatto un sabotage, sa che cosa significa? […], han/ hanno visto che io non sapëvo, non sapëvo, di sto Standard, di cose, mi hanno lasciato söla coṡì, mi söno impresssionata, dissi: – e ora cömu fàccio?
L’italiano popolare emerge sul piano morfologico (cömu per come) e lessicale (es. bellu pöṣto rifatto sul sic. beḍḍu pöstu lett. ‘bel posto’ inteso come ‘posto di lavoro ben retribuito’). D’altra parte, la sintassi presenta molti tratti tipici dell’oralità, come mostrano le numerose ripetizioni e le false partenze, l’epanalessi (ero troppo timida ero), l’aferetico sto per questo, il ricorso al generico cose, il discorso diretto (dissi: – e öra cömu faccio?), e l’uso dell’imperfetto nel periodo ipotetico in si era ora può darsi che avevo continuato ‘se fosse stato adesso può darsi che avrei continuato’, dove si osserva anche si per se (cfr. sic. si, ma anche fr. si). Non si può far a meno di notare poi la pronuncia palatale della fricativa preconsonantica, tipica dell’area sud-orientale della Sicilia (da dove proveniva il padre della donna), e la chiusura generalizzata (e sorprendente in contesto siciliano) delle vocali toniche medie, tanto quelle riconducibili a ō, ŭ e ū e a ē, ĭ e ī (come ad es. in occasiöni, avëvo, sapëvo, söla, cömu), quanto quelle riconducibili a ĕ e ŏ (come in pöṣtu ‘posto’), indipendentemente dal contesto (cfr. Valenti 2022: 660-661).
La complessità del repertorio è ben descritta dalle parole di RM quando, nel docufilm Siciliani d’Africa. Tunisia Terra promessa, parla della casa di riposo da lei gestita:
– Le Foyer familial “Delarue-Langlois” è una caṡa di accoglienza francëṡe, eṡiste dal 1944, elle a étais jujée d’utilité publique nel 1946, par décret beylicale. Eh, questa casa ha un qualcöṡa di mölto particolare, che öspita tutte le persöne che, secöndo me, è un pezzetto della störia della nostra Tuniṡia. Adesso abbiamo ventiçinque francëṡi, sette italiani, sei tuniṡini, e qui si parla francëṡe, si parla italiano, si parla tuniṡino, si festeggia Natale, si festeggia l’AID, tutte le feste söno benvenute, e poi, dëvo dire, che abbiamo una grande fortuna, di avëre delle persöne come Hediah, che si prendono cura dei nostri anziani con grande amöre. Hediah particolarmënte si öccupa degli italiani, dunque è cöme la löro mamma…
L’alternanza tra francese e italiano, osservabile nel parlato di RM, indizia una condizione di discreto bilinguismo francese/italiano, sia pure con un evidente sbilanciamento verso il francese, soprattutto sul piano fonologico. In generale, tale sbilanciamento appare ben evidente in molte altre delle produzioni orali delle persone intervistate, soprattutto donne che non hanno mai studiato l’italiano a scuola, come JG (classe 1940, intervistata il 27 luglio 2022), che dichiara di essere una “francese di origine italiana” e di saper parlare in italiano, sebbene la sua competenza dell’italiano si riveli nel corso di tutta l’intervista solamente passiva.
5. Conclusioni
La lingua italiana, ambita dalle prime generazioni degli emigrati, si impose a lungo e si mantenne nelle forme dell’italiano regionale (e talvolta popolare). L’italiano che emerge dalle trascrizioni, infatti, tradisce la provenienza della maggior parte degli intervistati dalla provincia di Trapani, quasi sempre marcato come è, sul piano fonologico, in direzione del siciliano di area occidentale (particolarmente per la chiusura delle vocali toniche medie, ma anche per il contorno intonativo, sebbene il dato rimanga al momento solo percettivo) e certo in direzione del francese (ad es. per la presenza della fricativa dentale sonora intervocalica). Tale varietà di siciliano dominante si impose per lungo tempo anche tra i parlanti provenienti da altre zone dell’isola, al punto che essi finirono con l’appropriarsi, se non di tutti, sicuramente dei tratti più marcati di quella varietà, come nel caso della chiusura delle vocali medie di cui si è detto (osservata per MAB). È, questo, l’unico elemento dialettale coinaico al momento rilevato e si pone nella direzione indicata da Pendola (2000a e 2000b) rispetto all’esistenza di una varietà sovralocale.
È chiaro che le differenze sono legate sia al livello di istruzione sia all’«adeguamento dell’individuo a comportamenti linguistici riferiti a un modello» (Turchetta 2018: 84), quello francese nel nostro caso. Alcune famiglie possedevano l’italiano nel repertorio di partenza, o ne vennero in possesso attraverso la scolarizzazione, e perseguirono la volontà di trasmetterlo ai figli mantenendone alto il livello (è il caso di CS, ACa, MR, RS, MJT, ACo); moltissime altre famiglie, pur avendo il solo dialetto come L1, optarono comunque per la trasmissione “attiva” dell’italiano-lingua di prestigio, (s)forzandosi di usarlo e determinate a trasmetterlo, anche a costo di abiurare al dialetto e anche in assenza di un apprendimento guidato, con risultati diversi in rapporto alle diverse esperienze di vita e di lavoro (come emerge dal parlato di MAB, JR, RZ, GT, RM). Intanto però, il francese si inseriva progressivamente nel repertorio e si affermava come lingua predominante e come si è detto in alcuni casi esclusiva (come si è osservato per CT, JG, PM).
D’altra parte, fu inevitabile che, dopo la seconda guerra mondiale, il francese si sostituisse progressivamente all’italiano nella comunicazione quotidiana e nella vita pratica. Da quel momento in poi, il numero degli italiani residenti in Tunisia si ridusse sensibilmente: da un censimento del 1946 gli italiani erano 84.935, ma nel successivo censimento del 1959 – cioè dopo l’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza dalla Francia – erano circa 52.000 (44.165 dei quali siciliani) e il loro numero si sarebbe ridotto esponenzialmente, sia per il processo irreversibile di tunisificazione della manodopera e la conseguente disoccupazione per gli stranieri, sia per il clima di paura determinato dall’uccisione di molti italiani (Finzi 2016: 58-62). Oggi gli italiani residenti in Tunisia sono complessivamente 7-8.000: oltre 3.000 rappresentano italiani di recente insediamento (moltissimi i pensionati), mentre gli altri si ascrivono variamente alla comunità storica (Faranda 2016: 8)25.
Il repertorio degli italotunisini si è ristrutturato completamente nell’arco di tre generazioni, invertendo la posizione e il ruolo dei codici. I dati presi in esame convergono nella direzione dell’inevitabile slittamento dell’italiano verso le posizioni più basse del repertorio, da cui tuttavia, per gli intervistati, non è ancora uscito del tutto (a differenza di quanto sta avvenendo invece per le ultime generazioni). Nel caso della Tunisia, sarà anche necessario capire in che modo il francese, finora predominante tra gli italotunisini più giovani, si adatterà a convivere con le istanze di affermazione dell’arabo tunisino, sempre più pressanti tra la popolazione locale.
Bibliografia
Alfonzetti, G. (2012), I giovani e il code switching in Sicilia, Palermo, Centro Studi Filologici e Linguistici siciliani.
Atzeni, F. (2011), Italia e Africa del Nord nell’Ottocento, «RiMe», Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 6: 785-810.
Bivona, M. (2019), L’ultima generazione, Besa Editrice, Lecce, 2019.
Boccara, Elia (2000), La comunità ebraica portoghese di Tunisi (1710-1944), La Rassegna Mensile di Israel, terza serie, vol. 66, n. 2 (Maggio – Agosto 2000), pp. 25-98.
Campisi, A. (2020), Enfants d’une histoire « mineure » : la collectivité sicilienne de Tunisie et le « danger sicilien », in Cettina Rizzo (ed.), Migrazioni. Storie, lingue, testimonianze, Aracne, Roma, 119-134.
Campisi, A., Pisanelli, F. (2015), Mémoires et contes de la Méditerranée. L’émigration sicilienne en Tunisie entre XIXe et XX siècles – Memorie e racconti del mediterraneo. L’emigrazione siciliana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo, mc-éditions, La Soukra.
Davin A. (1910), Les ltaliens en Tunisie, in «Revue de Deux Mondes», 5e période, tome 59, 1910 : 689-708.
Ducati F. (2021), Fluttuazioni commerciali tra nord Africa e Sicilia meridionale: il VI e il VII secolo d.C. Cignana come caso studio, in Mare Internum. Archeologia e Culture del Mediterraneo, 2021, 2020 (12): 85-97.
Faranda, L. (2016), Lasciateci stare. Pensionati italiani in Tunisia tra crisi, esili e dimissioni dello Stato, in Laura Faranda (ed.), Non più a sud di Lampedusa. Italiani in Tunisia tra passato e presente, Armando Editore, Roma: 139-166.
Finzi, S. (2000), Il progetto della memoria degli italiani di Tunisia (800-900), in Ead. (ed.), Memorie italiane di Tunisia – Mémoires italiennes de Tunisie, Finzi Edizioni, Tunisi: 5-6.
Finzi, S. (2000), La Camera di Commercio ed Arti, in Ead. (ed.), Memorie italiane di Tunisia – Mémoires italiennes de Tunisie, Finzi Edizioni, Tunisi: 41-52.
Jehel G. (2001), L’Italie et le Maghreb au Mayen Âge : conflict et échanges du VIIe au XVe siècle, Presses universitaires de France, Paris.
Malouch, S. (2008), Restructuring la Petite Sicile (“Little Sicily”) Town Quarter of la Goulette in Tunisia, in «Global Urban Development», Vol. 4, Issue 1, August 2008: 1-10.
Masi G. (2014), Quando i calabresi (e gli italiani) cercavano la «terra promessa» in Tunisia, in V. Cappelli, G. Masi, P. Sergi (eds.), La Calabria dei migranti. Partenze, rientri, arrivi, «Rivista calabrese di Storia del ’900», 2 (numero monografico).
Melfa D. (2006), Da proletari a proprietari: viticoltori italiani in Tunisia tra ’800 e ’900, in Cresti, Federico, Melfa Daniela (eds.), Da maestrale e da scirocco: le migrazioni attraverso il Mediterraneo (atti del convegno, Facoltà di Scienze politiche, Catania, 23-25 gennaio 2003), Giuffrè Editore, Milano: 121-148.
Melfa, D. (2008a), ‘Migrando a Sud’. Coloni italiani in Tunisia 1881-1939, Aracne, Roma.
Melfa, D. (2008b), Sguardi italiani sulle Piccole Sicilie di Tunisia, in «Quaderni del Dipartimento di studi politici»: 227-245.
Mori, A. (1936), Terra e nazioni, Vallardi, Milano.
Orfano, A. (2014), “Submerged” Italian in Tunis: Italian and Its Dialects as Heritage Language, in «Italian American Review» 4, n. 2: 125-146.
Pendola, M. (1999). Les mots de la memoire. Une approche linguistique de la présence italienne en Tunisie, in Leila Adda (ed.), Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du protectorat, Université de Tunis I, Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National, Tunis: 83-93.
Pendola, M. (2000a), La lingua degli italiani di Tunisia, in Silvia Finzi (ed.), Memorie italiane di Tunisia. Mémoires italiennes de Tunisie, Finzi Edizioni, Tunisi: 13-18.
Pendola, M. (2000b), Mangiare all’italiana in Tunisia : un caso di sincretismo culturale, in Silvia Finzi (ed.), Memorie italiane di Tunisia. Mémoires italiennes de Tunisie, Finzi Edizioni, Tunisi: 225-232.
Pendola, M. (2000c), La riva lontana, Sellerio, Palermo.
Pendola, M. (2004), Lingua. In http://www.italianiditunisia.com (in rete dal 2004). Consultato in data 25 agosto 2022.
Pendola, M. (2014), La traversata del deserto, Arkadia, Cagliari.
Rainero, R. (1999), La présence italienne en Tunisie de 1868 à 1896 d’après les bulletins diplomatiques et consulaires italiens, in Leila Adda (ed.), Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du protectorat, Université de Tunis I, Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National, Tunis : 19-30.
Sebag, P. (1991), Histoire des Juifs de Tunisie: des origines à nos jours, L’Harmattan, Paris.
Speziale, S. (2016), Gli italiani di Tunisia tra età moderna e contemporanea: diacronia di un’emigrazione multiforme, in L. Faranda (ed.), Non più a sud di Lampedusa: Italiani in Tunisia tra passato e presente, Armando Editore, Roma: 17-42.
Speziale, S. (2018), Più a Sud del nostro Sud: spunti e problemi per lo studio dell’emigrazione italiana in Arica mediterranea tra le due guerre, in Meridiana. Rivista di storia e Scienze sociali, 92 (Migrazioni e fascismo). Imes, Istituto meridionale di storia e scienze sociali, Viella: 95-116.
Trovato S.C., Menza S. (2020), Vocabolario del dialetto galloitalico di Nicosia e Sperlinga, Centro Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo.
Turchetta, B. (2018), Modelli linguistici interpretativi della migrazione italiana, in Turchetta, B. Vedovelli, M. (2018), Lo spazio linguistico dell’italiano globale: il caso dell’Ontario, Pacini, Pisa: 73-104.
Turchetta, B., Vedovelli, M. (2018) (eds.), Lo spazio linguistico italiano globale: il caso dell’Ontario. Firenze, Pacini.
Valenti, I. (2022a), Italiano residuale e resiliente tra discendenti dell’emigrazione italiana postunitaria in Tunisia. Un primo approccio, Studi Emigrazione, LIX, n. 228: 644-671.
Valenti, I. (2022b), Autobiografie (anche linguistiche): il bisogno di raccontarsi dell’italotunisino Marcello Bivona in L’ultima generazione (Besa edizioni, 2019). Con un’intervista all’Autore, in A. Bivona, C. Rizzo, (ed.), Migrazioni e appartenenze: identità composite e plurilinguismo, Mimesis, Milano-Udine: 251-264.
Valenti, I. (2021), Testimonianze di italiano regional(-popolare) nei primi romanzi di Marinette Pendola (Tunisi, 1948), in M. Dhouib, A. Campisi (eds.), Mediterraneo, Tunisi 2017-2019, Éditions universitaires Sotepagraphic, Tunisi: 529-545.
Valenti, I. (2019), L’italiano regional-popolare di matrice siciliana ne L’Erba di vento della scrittrice italotunisina Marinette Pendola (1948-), in C. Rizzo (ed.), Migrazioni. Storie, lingue, scritture, Quaderni di Comparatistica 8, CIRVI – Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, Moncalieri: 165-222.
Vedovelli, M. (ed.) (2011), Storia linguistica dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci, Roma.
Vedovelli, M. (2018), La ricerca in Ontario: questioni e ipotesi di lavoro, in Barbara Turchetta, Massimo Vedovelli (eds.), Lo spazio linguistico italiano globale: il caso dell’Ontario, Pacini, Firenze: 21-38.
VS = G. Piccitto, G. Tropea, S.C. Trovato, Vocabolario Siciliano, 5 voll., Centro Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1977-2002.
Weinreich, U. (2008), Lingue in contatto, con Premessa di Vincenzo Orioles e Introduzione di Giorgio Raimondo Cardona, nuova edizione [19531], UTET, Torino.
1 In relazione alla mia partecipazione al PRIN 2017 Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana nel mondo: nuove dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive, in qualità di componente dell’Unità di Ricerca dell’Università Internazionale degli Studi di Roma coordinata da Laura Mori (coordinatore nazionale Massimo Vedovelli) e al progetto dipartimentale Migrazioni e appartenenze: analisi delle strategie e dei metodi di costruzione di nuovi concetti identitari e ristrutturazione dei repertori linguistici, in qualità di responsabile dell’Unità di Ricerca “Fenomeni migratori e ristrutturazioni dei repertori linguistici tra passato e presente” (coordinatrice Concettina Rizzo).
2 La maggior parte proveniva dal Palermitano e dal Trapanese, ma tanti erano i siciliani originari anche di altre province (Ragusa, Caltanissetta, Agrigento).
3 A questo riguardo, si pensi alla consistente emigrazione “italiana” (marinai, operai, medici e commercianti) che interessò i territori della Barberia orientale dopo l’avvento delle Repubbliche marinare (El Houssi 2017); o agli insediamenti, di natura commerciale, di ebrei italiani provenienti da Livorno e da Ancona nel corso dei secc. XVII e XVIII (Sebag 1991). Si ipotizza che nel 1881 gli italiani residenti in Tunisia dovessero essere circa 25.000 (Atzeni 2011: 800).
4 Altri Paesi di destinazione furono Algeria, Libia ed Egitto.
5 Va detto però che doveva trattarsi di un flusso ininterrotto sin dall’antichità (si pensi particolarmente all’importanza di Cartagine nel mondo romano).
6 Gli esuli politici, costretti a lasciare l’Italia dopo il fallimento dei moti carbonari del 1820-21 e poi ancora dopo il 1833 e il 1848, rappresentarono «un punto di riferimento significativo per il futuro movimento patriottico tunisino», influenzando non poco il processo di modernizzazione del Paese voluto dal bey Ahmed tra il 1837 e il 1855 (Atzeni 2011: 789).
7 Tali famiglie di ebrei livornesi erano ben diverse da quelle degli ebrei socialmente meno abbienti (cfr. Melfa 2008a: 233), già presenti in Tunisia da antica data (Sebag 1991: 96).
8 Masi (2014: 30) ricorda la ricorrenza delle mete africane nella pubblicistica locale e nelle prime investigazioni ministeriali. Si veda ad es. il numero degli emigrati per l’Africa nel 1880 (117 contro gli appena 7 partiti per gli Stati Uniti d’America) riportato nella Relazione dell’on. Comm. Ascanio Branca, deputato al Parlamento, sulla seconda circoscrizione (provincie di Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria), negli Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola del 1883.
9 Secondo Rainero (1999: 24) erano invece 30.000.
10 Traggo queste informazioni dalla pagina web di Marinette Pendola <www.italianiditunisia.com/Storia/Approfondimento-07/frm-main.php?lingua=> (ultimo accesso: marzo 2019). Cfr. anche Campisi (2020: 126-130).
11 Cfr. Speziale (2016a e 2016b).
12 A Pendola (e al marito Edoardo Migliore, anch’egli italotunisino) si devono anche le pagine del sito http://www.italianiditunisia.com (in rete dal 2004), volto a salvaguardare e valorizzare la cultura degli italotunisini, nella consapevolezza dei forti valori di apertura e tolleranza in essa rappresentati, come si legge nella home page.
13 Penso ad opere scritte in italiano come quella di Giuseppe Gabriele, Quel centimetro in meno, Pessano c. Bornago (MI), Mimep-Docete, 2003; di Ferruccio Bensasson, Utopie perdute. Per un domani all’altezza dei nostri sogni, Roma, Aracne, 2008; di Marcello Bivona, L’ultima generazione, Lecce, Besa Editrice, 2019. Ma penso anche alle pubblicazioni in francese di Adrien Salmieri, Chronique des morts (Julliard 1974); Rosaire Di Stefano, À flanc de Bou-Kornine: recueil de souvenirs (Auto-Edition 1985); Benedetto Félix Pino (pseudonimo Sicca Venier), autore di raccolte di poesie come Braises et cendres (1994), Prélude lent (1999) e di opere in prosa come Bambochades tunisiennes (1984), Glanures (1989), Le joaillier de Dieu (1990), En marge d’un vieil évangéliaire (1998), Nouvelles bambochades tunisiennes (2002); Huguette Senia-Badeau, Entre Sicile et Tunisie (Saint-Denis, Société des Ecrivains 2009); Michel Auguglioro, La partenza (1887-1909); Besbessia. Saga d’une famille sicilienne de Tunisie (Editions Caraginoiseries, 2011).
14 Silvia Finzi è ordinaria di Storia dell’emigrazione italiana (dall’Ottocento ad oggi) nella la Facoltà di Lettere e Scienze Umane de La Manouba. Al suo impegno si devono le importanti pubblicazioni della casa editrice da lei ereditata dal padre, la Finzi Editrice di Tunisi: Pittori italiani di Tunisia (2000), Memorie italiane di Tunisia (2001), Architetture italiane di Tunisia (2002), Mestieri e professioni degli italiani di Tunisia (2004), Scrittori e poeti italiani di Tunisia (2007).
15 Tale opera è attualmente in fase di revisione e ampliamento.
16 Per citarne alcuni, Italiens de l’autre rive di Mohamed Challouf (60‚, 1989); Un été à la Goulette di Férid Boughedir (89‚, 1996); Ritorno a Tunisi di Marcello Bivona (durata 72′, 1997); Une frontière en miroirs di Stefano Savona (57′, 2002); Bastava una notte di Manuel Giliberti (60′, 2011); La maison d’Angela di Olfa Chakroun (26‚, 2010); Kif kif – Siciliani di Tunisia, di Fausto Giudice e Marinette Pendola (9.38‚, 2012); Marinette torna a casa di Enrico Montalbano e Laura Verduci (12.55‚, 2013); Siciliani d’Africa. Tunisia Terra promessa di Marcello Bivona e prodotto da Alfonso Campisi, con la collaborazione, fra gli altri, dell’Università di Catania (90′, 2021); Manca Moro, di Rim Temimi (86′, 2021).
17 Vd. nota precedente.
18 In questa sede, ringrazio (nell’ordine in cui compaiono nella tabella) Claudine Strazzera, Claudine Tumbarello, Antonio Caiola, Jeanne Gallo, Maria Antonietta Boscarino, Gabriele Torre, Pierre Manardo (attraverso Marcello Bivona), Marcella Raffaele, Rita Strazzera, Josette Randazzo, Marie-Jo Tumbarello, Rosina Zucca, Rita Mangogna, Angelo Corrao. Alle produzioni orali degli altri intervistati saranno dedicati ulteriori saggi.
19 Con la sola eccezione di CT e CS.
20 Relativamente all’interazione tra i bi-/trilingui italotunisini e gli intervistatori, in considerazione della “restrizione dell’interlocutore” segnalata Weinreich (2008: 120), ho cercato, ove possibile, di incrociare i dati desumibili dalle interviste con quelli ricavati dall’osservazione diretta.
21 Sul piano testuale, i segni paragrafematici assumono i seguenti valori: <, > = pausa breve; <. >= pausa lunga; <…> = esitazioni; <?> = interrogative; <!> = esclamative; [ = enunciati sovrapposti; […] = frammenti non riportati; [?] = passaggi oscuri; / = autointerruzioni; <ːːː> = allungamenti fonologici di vocali ((xxx)) = interventi di chi trascrive (cfr. Alfonzetti 2012).
22 Il bagi(t)to era una varietà giudeo-italiana, parlata dagli ebrei livornesi, formatasi tra Seicento e Ottocento nel porto franco mediceo di Livorno (Franceschini 2006).
23 Va però sottolineato che il mantenimento dell’italiano ha costituito una priorità tra gli ebrei livornesi e non è un caso che ancora oggi si pubblichi, ad opera della casa editrice Finzi, il “Corriere di Tunisi”, l’unico giornale in lingua italiana del nord Africa.
24 Segnalo, ad es., il mancato rispetto della struttura argomentale, nella sequenza quelli rimpatriati di là, della Sardegna, della Sicilia ‘quelli rimpatriati da là, dalla Sardegna e dalla Sicilia’, nella quale affiora la costruzione tipica del dialetto con l’uso della prep. di per indicare provenienza, in luogo dell’it. da; nel costrutto ci siamo passati qua cinquant’anni, accanto all’uso pleonastico dell’avverbio ci, si evidenzia il ricorso all’ausiliare essere al posto di avere, probabilmente per ipercorrettismo a partire dal siciliano amu passatu ‘abbiamo passato’ (ma non senza l’interferenza del francese); sul piano morfologico, annoto la preposizione, chiaramente siciliana, fina per fino a; l’avverbio puru per pure; quartodicianni per quattordicianni; il pl. scuoli per scuole; mparatu per ‘imparato’ (cfr. Valenti 2022: 663-664).
25 In alcuni casi, si è osservato anche il rientro in Tunisia dei figli di coloro che la lasciarono negli anni Sessanta del Novecento, nati o meno che fossero sul suolo tunisino.