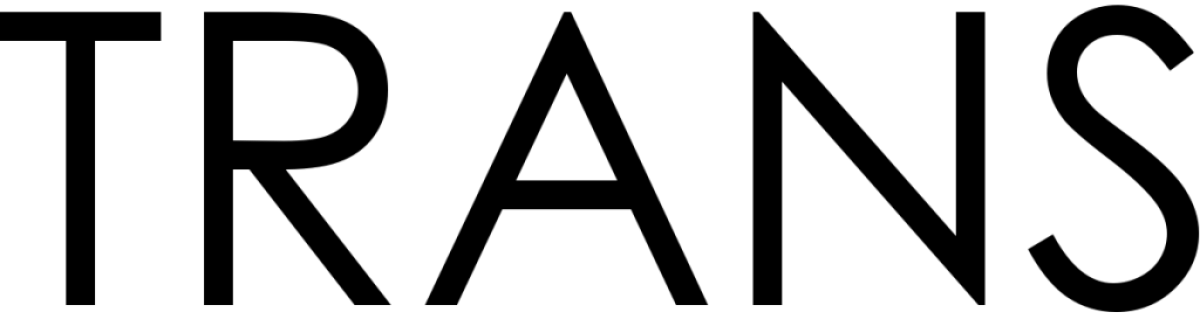Veronica Benzo
(Università degli Studi di Catania)
vbenzo@unict.it
Abstract
Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität sind zwei Schlüsselbegriffe in der heutigen Gesellschaft. Kulturelle Unterschiede können die Aushandlungen zwischen wirtschaftlichen Realitäten, die in unterschiedlichen geopolitischen Kontexten agieren, ernsthaft gefährden. Die Erfahrung von Amélie Nothomb, Autorin des stets aktuellen Buches Stupeur et tremblements, dient als Fallstudie, um einige kulturelle Unterschiede zu untersuchen, die sich auf die Arbeitsbeziehungen auswirken können. Die Analyse wird in den Kontext der acht EU-Schlüsselkompetenzen gestellt.
Plurilinguismo e pluriculturalismo sono due concetti chiave nella società odierna. Le differenze culturali possono mettere a serio rischio le negoziazioni tra realtà economiche che agiscono in contesti geopolitici diversi. L’esperienza raccontata da Amélie Nothomb, autrice di Stupeur et tremblements, sempre attuale, costituisce un caso studio per esaminare alcune differenze culturali che possono incidere nelle relazioni lavorative. L’analisi viene contestualizzata nel panorama odierno delle otto competenze chiave dell’UE.
Multilingualism and pluriculturalism are two key concepts in today’s society. Cultural differences can seriously jeopardise negotiations between economic realities acting in different geopolitical contexts. The experience recounted by Amélie Nothomb, author of Stupeur et tremblements, provides a case study to examine some of the cultural differences that can affect labour relations. The analysis is contextualised in today’s panorama of the eight EU key competences.
Introduzione
Questo contributo si inserisce nell’ambito di un progetto interuniversitario di ricerca Genova-Catania, Polyphonie1, che costituisce senza dubbio un’importante risposta all’attuale contesto socio-politico, culturale ed economico caratterizzato dai nuovi equilibri del sistema globalizzato.
L’Unione europea ha sempre difeso la diversità linguistica e, a tal fine, ha portato avanti una serie di raccomandazioni volte a preservare il plurilinguismo e l’identità culturale dei singoli Stati/cittadini. In particolare, il Consiglio d’Europa sin dalla sua fondazione (1949) promuove, tramite convenzioni, raccomandazioni e strumenti tecnici, i diritti umani e la democrazia, valori che costituiscono le fondamenta della sua politica linguistica2.
Per valorizzare il plurilinguismo e il pluriculturalismo, risulta di fondamentale importanza coniugare le diverse prospettive di ricerca al fine di promuovere sul nostro territorio questi due principi cardine. È proprio su queste due parole chiave che ci concentreremo nella prima parte del nostro lavoro. Abbiamo infatti constatato che, anche in ambito imprenditoriale, c’è ancora poca predisposizione ad aprirsi concretamente verso l’altra cultura per comprenderla laddove intervengono fattori extralinguistici quali la psicologia, la cultura generale, il buon senso comune.
La nostra esperienza sul plurilinguismo è iniziata con il Convegno itinerante organizzato dal Dorif3 nel 2012 e che ha coinvolto 19 Atenei, tra cui l’Università di Catania4. Abbiamo orientato la nostra attenzione verso il settore occupazionale della Sicilia orientale, creando sul territorio una rete di collaborazioni tra Istituzioni e imprese locali che rimane ancora attiva e che col tempo è diventata più fitta. Tale rete viene inoltre sfruttata per cercare di rendere ottimale l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti e ci ha permesso di osservare più da vicino le realtà aziendali che hanno avviato un processo di internazionalizzazione e che hanno riscontrato notevoli difficoltà nelle relazioni interculturali. A volte un messaggio imposto secondo il proprio modello relazionale e non veicolato nel modo più appropriato può determinare il fallimento di una trattativa importante o di una grande opportunità di arricchire il proprio portfolio clienti. Sono innumerevoli i casi di incomprensione interculturale che gli imprenditori siciliani hanno raccontato ai nostri studenti durante le numerose visite aziendali che abbiamo organizzato5. Questi fraintendimenti hanno naturalmente comportato una grave perdita economica in termini di investimento e di mancata opportunità. Inoltre, abbiamo potuto rilevare che la maggior parte delle aziende locali, pur attribuendo la giusta importanza a sufficienti competenze linguistiche (con un quasi monopolio della lingua inglese), non hanno preso in considerazione altri aspetti sopra accennati, soprattutto quelli interculturali6. Rari sono stati i casi di aziende che hanno invece ritenuto strategico l’affidamento di ogni mercato di riferimento ad un export manager (possibilmente di madrelingua) o comunque ad un esperto che abbia come pre-requisito la padronanza non solo della lingua ma anche della cultura di quel mercato; rari sono i casi di aziende che hanno addirittura ritenuto strategico assumere un madrelingua per gestire le relazioni interculturali.
Willy Brandt, ex Cancelliere tedesco, in un suo discorso di diversi anni fa aveva sottolineato l’importanza del plurilinguismo e di rivolgersi a ciascun interlocutore nella sua lingua e non nella propria lingua:
« Se voglio vendervi qualche cosa, parlo la vostra lingua, se voglio comprare qualcosa, siete voi che dovete parlare la mia lingua»
« Si je veux vous vendre quelque chose, je parle votre langue. Si je veux vous acheter quelque chose, dann müssen Sie Deutsch sprechen »
Aggiungiamo a quest’affermazione che occorre comunicare non solo nella lingua dell’acquirente, ma soprattutto nel rispetto degli usi e dei costumi dello stesso. La mancata conoscenza di alcune informazioni porta ad un’interpretazione errata di determinati comportamenti, come potrebbe essere la gestione del proprio spazio fisico, concepito diversamente nelle varie culture. Balboni7 sottolinea che il corpo ha bisogno di una distanza di sicurezza e che
viviamo dentro una sorta di “bolla” il cui raggio [per le culture nord-mediterranee] è di un braccio teso: chi entra nella bolla ci “assale”. Ma [se] un mediterraneo entra senza problemi nella bolla altrui, tocca l’interlocutore, lo prende a braccetto, […]
un settentrionale sarebbe invece infastidito da una tale “invasione” della propria sfera privata; un giapponese attribuirebbe ad un tale atteggiamento una connotazione sessuale mentre nel mondo arabo risulterebbe del tutto normale stare gomito a gomito8.
Come è noto ai linguisti, parlare un’altra lingua non significa semplicemente utilizzare i costrutti corretti, ma implica anche la condivisione di una cultura che, come evidenzia Galisson, non è semplicemente una Cultura “avec un grand C”9 (letteratura, arte, storia, geografia, musica, ecc.), ma deve comprendere la cultura “avec un petit c”10 ovvero tutto ciò che resta solitamente sommerso pur condizionando le relazioni interpersonali e il buon fine di negoziazioni tra imprese operanti in contesti socio-culturali diversi. Abbiamo riscontrato come questi concetti purtroppo siano trascurati o sconosciuti dai non-linguisti e dagli imprenditori, che spesso si trovano a non comprendere perché una negoziazione sia fallita.
Questo, in breve, è il quadro teorico-pratico che ci ha spinti ad intraprendere un lavoro di sensibilizzazione dei nostri studenti e ci ha portato ad analizzare il romanzo Stupeur et tremblements come caso studio per comprendere l’importanza della mediazione culturale e del rispetto delle prassi altrui.
-
Stupeur et tremblements: il parametro dell’interculturalità.
Stupeur et tremblements ha avuto un successo a livello mondiale, è stato tradotto in ben 27 lingue e ha ottenuto il prestigioso premio dell’Académie Française – il riconoscimento più importante da parte del mondo letterario francese. L’esperienza raccontata dall’Autrice ha costituito per noi e costituisce tutt’ora un caso studio da esaminare, sia attraverso il film sia attraverso il romanzo in quanto ci permette di riprende diversi aspetti soprattutto culturali. Già il titolo contiene di per sé una connotazione interculturale in quanto ricorda un protocollo imperiale che imponeva di presentarsi all’imperatore con “stupore e tremori”. La protagonista del romanzo, Amélie, influenzata dalla cultura europea, si ritrova a manifestare “stupore”, ovvero sbalordimento, verso tutto ciò osserva e che si rivela incomprensibile ai suoi occhi. Questo stupore, associato alla concezione giapponese dell’inferiorità del cervello occidentale rispetto a quello nipponico, deve essere accompagnato da “tremori” (tremblements) che evidenziano l’inferiorità e la sottomissione, senza alcun atteggiamento che possa essere interpretato come una resistenza. Oggi, nel mondo del lavoro europeo sono riconosciute diverse manifestazioni di resistenza o comunque di disappunto: lo sciopero (che può essere pianificato anche a livello nazionale, come nel caso dei gilets jaunes o delle contestazioni per la riforma delle pensioni in Francia), l’inerzia, il silenzio, l’assenteismo… sono tutte forme di comunicazione che vengono esaminate durante le nostre attività formative in quanto vanno usate opportunamente e nel rispetto dell’organigramma, che rappresenta una struttura gerarchica da rispettare, ma soprattutto devono essere ben interpretate. Per i cinesi, ad esempio, osservare il silenzio prima di prendere la parola è segno di rispetto; per gli occidentali il silenzio è invece imbarazzante, ma anche espressione di una volontà ben precisa di non comunicazione.
Il concetto di rigore, insito nel titolo, in ambito professionale può assumere una connotazione del tutto relativa in base alle culture di riferimento. La protagonista del romanzo, Amélie, durante il suo stage, riesce a coniugare l’afferenza a due culture diverse, in quanto
-
da una parte osserva quanto accade con un filtro culturale europeo che le permette di denunciare il modello giapponese, la condizione del dipendente in contesto lavorativo e la condizione della donna; lo si può evincere dagli attributi associati ad ogni personaggio: Fubuki Mori è “sublime et détestable”, il sig. Saito appare come un essere debole fisicamente e psicologicamente (petit et malingre), il Sig. Tenshi (l’unico che le affiderà un compito dignitoso) viene visto come la personificazione di un angelo, mentre il vice presidente, il sig. Omochi, dalla figura obesa, incarna il diavolo, mostrando tutta la sua “laideur morale”;
-
dall’altra parte riesce a sopportare le situazioni più difficili, facendo prevalere lo spirito di adattamento al contesto lavorativo e alla cultura del paese che porta la giovane a rispettare la filosofia dei Samurai secondo la quale “le combattant ne devrait jamais montrer de marques de suffrances”11. Questa regola, rispettata da Fubuki quando viene ripresa dal proprio superiore, viene sistematicamente osservata anche da Amélie che, nonostante i vari rimproveri e nonostante la sua esperienza che sembra piuttosto “une longue descente aux enfers”, riesce a “riposizionarsi” dopo ogni fallimento e il conseguenziale cambio di compito, senza mostrare segni di cedimento. Piuttosto che presentare le dimissioni, come avrebbe fatto qualsiasi occidentale, Amélie decide di onorare il contratto di stage fino alla scadenza, nel pieno rispetto della cultura giapponese che avrebbe inteso l’abbandono come una perdita di dignità. Tenta così, con questa decisione, di reintegrarsi fino alla fine nella società nipponica.
Anche allo scadere del contratto rispetta pienamente le regole orientali. Amélie, come previsto dal sistema, ripercorre la struttura gerarchica e manifesta a ciascuno dei suoi superiori la volontà di non voler rinnovare il contratto; inoltre fa ricadere su di lei la responsabilità di questa decisione, non mettendo in discussione il sistema nipponico, che ai suoi occhi di europea era comunque distorto. In contesto lavorativo, sia occidentale che nipponico, quest’atteggiamento sarebbe espressione di una responsabilità sociale così come previsto in seno alle 8 competenze chiave dell’UE.
Il romanzo ci permette inoltre di introdurre il tema dell’identità/alterità in un contesto in cui ci si orienta principalmente a studiare come palesare l’identità di un’impresa o di un prodotto al fine di poter essere competitivi. Le analisi di mercato sono influenzate dal filtro culturale di chi le conduce e spesso trascurano l’aspetto dell’interculturalità. Una disamina più profonda che consideri l’Altro permetterebbe di evitare di usare degli slogan, di portare avanti delle campagne pubblicitarie o di dare il nome ad un prodotto che in certi contesti potrebbe mostrarsi fallimentare, come lo testimoniano innumerevoli esempi come quello della nota marca dell’acqua tonica Schweppes che, in occasione di una campagna pubblicitaria, ha veicolato il suo prodotto come « Eau de toilette Schweppes »; oppure la nota marca Puma, che per festeggiare i 40 anni della nascita degli Emirati Arabi, ha immesso sul mercato delle scarpe da tennis con i colori della loro bandiera. Purtroppo, l’azienda Puma ha dovuto fare i conti con il fatto che per gli Emirati la concezione della scarpa è diversa dalla nostra perché rappresenta un simbolo di sporcizia e impurità che ha determinato un sentimento di indignazione per aver associato i colori della bandiera con quelli delle scarpe. Gli esempi fallimentari sono innumerevoli. Da ciò si evince che a volte l’identità di una marca può essere compromessa se non si tiene conto del concetto di alterità del mercato che si vuole penetrare.
Prestando attenzione a non stereotipare gli usi e i costumi, abbiamo cercato di prendere spunto da alcune sequenze del romanzo e le abbiamo contestualizzate alfine di un inserimento ottimale nel mondo del lavoro.
Il legame che l’Autrice ha instaurato con la lingua e la cultura giapponese è certamente forte e viene dalla stessa custodito gelosamente anche durante i vari trasferimenti del padre e della sua famiglia da un luogo ad un altro per motivi di lavoro; negli anni questo legame assume un significato davvero unico perché per l’Autrice lingua e cultura, unici beni trasportabili, permettono di salvaguardare la sua doppia identità nipponica-europea. Tuttavia, se normalmente il concetto di identità viene contrapposto a ciò che è esterno, a ciò che è diverso o all’Altro, nel caso di Amélie l’allontanamento dal Giappone la porta a vivere una vita la cui identità non sarà più chiara e nitida, ma si collocherà in una sorta di “entre-deux culturel”. Realtà e immaginazione si combineranno nel tempo in un profilo in cui la protagonista sarà sempre alla ricerca di un’identità che, nei fatti, non ritroverà più in quanto non le appartiene più. Il suo paese natale, il Giappone, avrebbe dovuto accoglierla e restituirle l’identità che il suo vissuto le aveva sottratto. In realtà, la protagonista si ritrova in grande difficoltà a riadattarsi al contesto nipponico a causa dell’opposizione da parte degli stessi giapponesi che la definiscono “une Blanche.. qui comprenait leur langue”. Non si tratta di un episodio isolato di puro razzismo. Spesso infatti vengono rivolti giudizi molto severi alla giovane anche da parte di Fubuki, la sua superiore, che la umilia fino ad associarla alla categoria “des handicapés mentaux”: il razzismo, secondo la concezione occidentale, si spinge qui “au harcelèment”, ovvero a vere e proprie manifestazioni di mobbing sul lavoro. Anche in questi casi prevale lo spirito di adattamento al contesto lavorativo e alla cultura del paese in cui svolge lo stage che porta la giovane a rispettare le regole.
-
Stupeur et tremblements e le 8 competenze chiave dell’UE.
L’attenzione per il Giappone è scaturita dal dialogo e dalle collaborazioni con alcune imprese operanti sul territorio siciliano che hanno manifestato qualche difficoltà nel gestire le negoziazioni con l’Oriente. In effetti il mondo del lavoro è in continua trasformazione, il che comporta per i nostri giovani uno scoraggiamento legato alle notizie negative che i media veicolano giornalmente. Le imprese locali, da parte loro, lamentano una carenza di competenze chiave nei neolaureati, tanto che le stesse sono spesso portate a cercare candidati all’estero per poter ricoprire alcune posizioni lavorative nel territorio in cui operiamo. Al contrario, alcune realtà imprenditoriali come Eurodisney cercano candidati in Sicilia per via di alcune caratteristiche fisiche e caratteriali. Il mercato del lavoro, dunque, è molto dinamico e “liquido”, come lo definirebbe Zygmunt Bauman12. Domanda e offerta di lavoro si combinano e trovano equilibri sempre diversi. È il mercato che determina l’importanza di possedere determinate hard skills e quindi quali competenze linguistiche sviluppare.
Nel 2006 l’UE ha individuato e sintetizzato otto competenze chiave che tutti i giovani dovrebbero possedere per entrare nel mercato del lavoro. Le prime due competenze sono rispettivamente “saper comunicare nella propria lingua” e “saper comunicare in lingua straniera”. La protagonista del romanzo ha maturato queste due competenze, anticipando già negli anni ’90 ciò che oggi è (dovrebbe essere) un prerequisito per accedere all’impiego. Amélie, come tutti coloro che hanno genitori di due nazionalità diverse, ha avuto una grande opportunità: la possibilità di apprendere, parlare, dialogare in più lingue, coltivando l’interesse verso la cultura giapponese che rappresenta per lei le proprie radici: l’infanzia, la figura della madre e della nonna materna. I ricordi indelebili di un bambino, legati a momenti di gentilezza e affetto con le due figure femminili più importanti spingono la protagonista ad alimentare questo legame, acquisendo quella spontaneità tipica di una madrelingua e interiorizzando anche quel savoir-faire che contraddistingue una società, conoscendo alcuni riti e alcune espressioni che solo un indigeno può conoscere. Il limite però sta nel fatto di generalizzare le competenze acquisite, senza preoccuparsi di distinguere sfera privata e sfera professionale ed ancora, senza un approccio interculturale in ambito lavorativo. D’altronde anche questo è un limite relativo, perché nei fatti Amélie sentiva di essere giapponese. Erano i Giapponesi che non la consideravano tale e le facevano pesare il suo status di ragazza europea.
Dopo anni di mobilità vissuta come un continuo sradicamento dalla propria zona di comfort rappresentata dagli anni dell’infanzia vissuti in Giappone, la protagonista decide di vivere un’esperienza lavorativa che possa restituirle quell’identità a cui aveva dovuto rinunciare per diversi anni, ma che aveva custodito e condiviso con la madre. Lavorare presso una grande impresa giapponese, la compagnia Yumimoto, e integrarsi nella società nipponica rappresenta per Amélie un grande sogno che si realizza. Così, si presenta per il suo primo giorno di lavoro ed ha subito la sensazione di ritrovarsi in un ambiente molto rigido. L’Autrice, descrivendo il suo ingresso nell’azienda, ha come la sensazione che l’ascensore letteralmente la “sputò” (in francese l’autrice usa il verbo “cracha”) all’ultimo piano dell’edificio. La scrittrice racconta
“l’ascenseur me cracha au dernier étage de l’immeuble Yumimoto. La fenetre, au bout du hall, m’aspira comme l’eut fait le hublot brisé d’un avion”.
L’ascensore, che serve a trasportare verticalmente le persone nei vari piani dell’edificio, rigetta la protagonista al 44° piano del grattacielo, come se volesse liberarsi di un corpo estraneo, di un intruso, alla stregua del sistema di area condizionata per purificare l’area. L’ascensore la scaraventa dunque nel vuoto, nessuno si interessa a lei e immediatamente si sente esclusa ed estranea al sistema. I primi minuti all’interno di questo imponente edificio già sono marcati dalla prima infrazione delle regole professionali in quanto dimentica di presentarsi in segreteria. Questa primo errore viene subito messo in evidenza dal suo superiore gerarchico, Signor Saito, che le chiede con tono severo il motivo per cui non abbia avvertito l’acceuil del suo arrivo.
Allorché prepariamo i nostri studenti sul français des affaires, prestiamo particolare attenzione a tutti i rituali dell’accoglienza in un’impresa, come deve comportarsi l’ospite e come deve comportarsi l’hôtesse d’accueil e quali sono le formule più adatte dal punto di vista professionale. Prestiamo particolare attenzione alle formule utilizzate. Ad esempio, “Comment puis-je vous être utile?” (Come posso aiutarla?) è senza dubbio l’espressione che mette maggiormente l’ospite a proprio agio, in quanto distende gli animi e dà subito l’idea di essere ben accolto nella struttura, in quanto sin dall’“accueil” (l’accoglienza) il personale si mostra disponibile ad aiutare e fare tutto il necessario per soddisfare le esigenze del visitatore. La frase pronunciata dal Signor Saito “perché non ha avvertito la segretaria del suo arrivo?” (pourquoi n’avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée?) certamente non ha la finalità di mettere a proprio agio la stagista, anzi sembra piuttosto voler evidenziare l’errore commesso, né contiene un messaggio sottinteso volto a dare un’ (in)/formazione o un consiglio ad una ragazza, che seppur bilingue, è straniera e per la prima volta si approccia ad un contesto professionale del tutto nuovo.
Il tour dell’azienda illustra la sua organizzazione: spazi condivisi e spazi rigorosamente privati, come l’ufficio del presidente la cui porta chiusa viene indicata e introdotta con “aria” solenne, nel pieno rispetto dei ruoli dell’organizzazione.
Il primo compito assegnatole consiste nello scrivere una lettera di risposta ad un invito a giocare a golf. Uno dei principi di base nella comunicazione, ed in particolar modo nella comunicazione commerciale, consiste nel creare un messaggio coerente al discorso con l’interlocutore, come se fosse un pezzo di un puzzle che deve combaciare con l’altro pezzo. Inoltre, deve inserirsi senza forzare la mano in quanto anche lo stile e il registro linguistico utilizzato devono rispettare il profilo dell’interlocutore. Non esistono lettere passe-partout, ma ogni lettera va pensata e calibrata in base al destinatario. La domanda di Amélie volta a conoscere chi fosse il destinatario è quindi del tutto legittima. Tuttavia, anche in questa circostanza, emerge il sistema rigidamente gerarchico della società nipponica, che non legittima chi sta gerarchicamente al di sotto a porre domande volte ad accedere ad informazioni confidenziali. Il sospiro di insofferenza del Signor Saito non è certamente volto a mettere, anche in questa circostanza, a proprio agio la stagista. Nonostante Amélie non abbia chiaro il compito accetta la sfida che si rivela fallimentare sin dal primo tentativo. È vero che una delle competenze chiave è quella di avere spirito di iniziativa ed essere intraprendenti, ma ciò che insegniamo ai nostri studenti nel percorso di français des affaires è comunque il rispetto delle procedure e la coerenza: se non si possiedono alcune competenze, bisogna comunicarlo umilmente, piuttosto che improvvisare. Giudicando in un primo momento il compito semplice, la ragazza sottovaluta l’importanza di lavorare su obiettivi precisi.
Più volte Amélie prova ad essere intraprendente, nella speranza di farsi notare. Al contempo, la ragazza si rende subito conto di non avere nessun ruolo all’interno dell’azienda e che fino a quel momento le competenze per le quali era stata selezionata non le erano servite a niente. Nessuno sembra interessato alle sue attitudini, né tanto meno alla sua presenza. Amélie si trova a trascorrere diverse ore in ufficio senza alcuna mansione. Nessuno le chiede di fare qualcosa, solo il Signor Saito le domanda di portargli il caffè. L’unica attività possibile è quella di stare ad osservare e di imparare le abitudini di tutti. Portare la bevanda giusta a ciascuno all’ora esatta in cui erano soliti prenderla è di fatto il suo lavoro.
Una mattina, arriva il giorno tanto atteso per dimostrare che il suo profilo era adeguato al posto di lavoro occupato, le viene chiesto di portare 20 caffè durante un’importante riunione per ricevere una delegazione di un’azienda amica. Conoscendo l’onorevole cerimonia del tè13 (l’ochakumi), Amélie prende sul serio il compito e serve la bevanda abbassando gli occhi e inchinandosi. Era per lei l’occasione finalmente di dimostrare di appartenere a quella cultura e che l’azienda aveva scelto la candidata giusta. Un comportamento adeguato sarebbe dovuto rientrare in ciò che l’azienda giapponese avrebbe dovuto pretendere, avendo assunto per un anno una ragazza bilingue e avendo sottoposto a diverse prove selettive la candidata. Ma si arriva al paradosso: la delegazione si sente offesa dall’uso di formule di cortesia talmente perfette che lasciavano intuire una perfetta conoscenza della cultura giapponese:
“je servis chaque tasse avec une humilité appuyée, psalmodiant les plus raffinées des formules d’usage, baissant les yeux et m’inclinant.”
Come avrebbero potuto sentirsi a loro agio con una bianca che capiva la loro lingua se si considera che per loro l’uso del giapponese da parte di un occidentale è un vero e proprio affronto, tanto da compromettere le relazioni tra imprese amiche. Le si ordina dunque di non conoscere più il giapponese, anzi di non comprenderlo più…
“Vous ne connaissez plus le japonais. C’est clair?
“Je vous donne l’ordre de ne plus comprendre le japonais”14
come se fosse possibile dimenticare una lingua (!). Di fronte allo sfogo di Amélie, che pronuncia parole offensive nei confronti della dirigenza, le viene risposto
“Calmez-vous. L’ordre ne venait pas de lui. Il transmettait les instructions de monsieur Omochi. Il n’avait pas le choix”15.
Amélie pensa di andare a lamentarsi con il presidente, ma le viene spiegato che non è opportuno andare da lui. Il tema del rispetto dei ruoli nel mondo del lavoro permette di fare una serie di riflessioni su come ci si relaziona nei vari contesti professionali, nel quadro delle competenze chiave dell’Europa; tuttavia, non va trascurato che l’identificazione in una determinata posizione lavorativa in una certa struttura lavorativa permette ad un qualsiasi lavoratore occidentale di trovare quelle coordinate motivazionali che lo spingono a fare sempre meglio. Amélie si ritrova ad esaminare una quantità di dossier senza uno scopo ben preciso; è per questo che ritiene più utile imparare tutti i nomi dei dipendenti e trova autonomamente l’applicazione pratica di quell’attività svolta: comincia a distribuire la posta, senza chiedere il parere di nessuno. La protagonista, affermando che
“il fallait que j’aie l’air de m’occuper”16,
desidera dimostrare di essere attenta, precisa, disponibile… insomma vuole posizionarsi all’interno dell’impresa. Tale bisogno si palesa quando si ritrova a conoscere a memoria tutti i nomi dell’organigramma, ma senza comprendere che esso andava rispettato nella sua struttura e che non doveva esserci sovrapposizione di ruoli. Anche in questo caso viene ammonita dal Signor Saito che le fa notare che “rubare il lavoro a qualcuno è una pessima azione”.
Se la raccomandazione dell’UE contempla tra gli obiettivi lo sviluppo dello spirito di iniziativa, ovvero l’attitudine di passare dalla teoria alla pratica in maniera efficace e costruttiva, la creatività e l’innovazione, la società nipponica condanna ogni operato che sia frutto di iniziativa individuale. Anche un’attività ingenua come quella di aggiornare i calendari viene concessa a patto di non alterare l’equilibrio lavorativo.
Incaricata successivamente di effettuare fotocopie inutili come atto punitivo, Amélie anche in questa circostanza cerca di fare del proprio meglio, mirando ad eseguire un lavoro perfetto anche quando si rende conto che, a prescindere dalla resa, il lavoro le verrà sempre contestato. Dopo diverse esperienze negative, le si presenta l’occasione per rimediare a tutti i fallimenti, quella che potrebbe permetterle di dimostrare le proprie competenze: la collaborazione con il Signor Tenshi – responsabile del settore caseario – che le chiede un rapporto il più possibile dettagliato su un nuovo burro light da esportare in Belgio (Paese che Amélie conosceva molto bene in quanto aveva vissuto lì per molto tempo). La relazione è perfetta e le apre la prospettiva di una rapida promozione. La sua superiore, la Sig.na Fubuki – una bellissima donna agli occhi di Amélie, descritta come una dea, con un posto di responsabilità non comune nelle società nipponica, dedita unicamente al lavoro, ma ancora nubile a 29 anni – non può sopportare una tale ingiustizia e denuncia il fatto ai propri superiori che condannano immediatamente l’accaduto.
Amélie potrebbe rappresentare per l’azienda una figura di mediatore culturale, fungendo da tramite tra due culture così diverse e, dimostrando di avere le competenze per finalizzare qualsiasi incarico; ottiene in tempi record dei risultati più che soddisfacenti. In prospettiva, il suo lavoro potrebbe, potenzialmente, comportare un notevole incremento delle relazioni internazionali; invero, tali specifiche competenze in materia di consapevolezza, espressione culturale, sociale e civica, l’attitudine a partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e professionale raccomandate dall’UE sono, invece, interdette in Giappone.
Conclusione
Il romanzo si presta senza dubbio a diverse tipologie di analisi: sociologica, del testo, introspettiva, della condizione della donna in Giappone, ecc.
L’uso del caso preso in questione ci ha permesso di esaminare vari aspetti interculturali riesaminando il romanzo dopo circa 20 anni dalla sua pubblicazione e di contestualizzarlo nell’attuale scenario lavorativo globalizzato. Amélie viene assunta per la conoscenza della lingua, tuttavia il suo stage si trasforma in un calvario che le fa subire una serie di comportamenti umilianti che in altri contesti socio-culturali sarebbero stati denunciati come atteggiamenti di mobbing. Nonostante lo/i “stupeur et tremblements”17, non riesce comunque ad integrarsi.
In particolare, è stato possibile:
-
aprire un percorso di riflessione più settoriale in cui lingua, usi e costumi determinano i vari equilibri relazionali;
-
introdurre nel dipartimento di Economia di Catania degli approfondimenti di marketing e management interculturale in lingua straniera;
-
sensibilizzare studenti e colleghi sull’importanza dell’apprendimento di più lingue straniere;
-
incentivare la mobilità internazionale al fine di un confronto con una cultura differente dalla propria;
-
approfondire i due concetti di plurilinguismo e pluriculturalismo, inserendoli in campo formativo-imprenditoriale;
-
esaminare il romanzo in modo dicotomico, prendendo in esame il modello europeo delle competenze chiave e dimostrare che queste stesse competenze non sono valide urbi et orbi;
-
coniugare diversi obiettivi didattici finalizzati alla formazione dei nostri studenti e attraverso un romanzo – difficilmente oggetto di studio in un dipartimento di economia – abbiamo potuto sensibilizzare e coinvolgere i giovani, predisponendo un percorso di preparazione al mondo lavorativo.
Piuttosto che elencare ai nostri studenti delle competenze da raggiungere per un ottimale inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo preferito partire da un modello culturale diametralmente opposto al nostro per poi spiegare come affrontare i vari contesti lavorativi in un mercato globalizzato. Tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie alla collaborazione con le aziende con le quali abbiamo interagito. Dalle varie visite aziendali da noi organizzate, abbiamo potuto trarre molteplici spunti di riflessione, applicandoli successivamente nella nostra didattica dell’insegnamento della lingua francese. Tra le diverse attività formative, abbiamo analizzato con i nostri studenti il romanzo “Stupeur et tremblements” da una prospettiva interculturale che ha permesso di mettere in evidenza le riflessioni sopra esposte.
Stante che ancora sul nostro territorio c’è poca attenzione verso l’aspetto interculturale, sia a livello istituzionale sia a livello imprenditoriale, stiamo portando avanti il nostro progetto di sensibilizzazione sull’importanza di questi temi raccogliendo i primi riscontri positivi. Infatti, i nostri stagisti sono maggiormente apprezzati nel momento in cui si inseriscono in ambito professionale all’interno delle aziende partner.
BIBLIOGRAFIA
British Council (2012), Language Rich Europe. Tendenze nelle politiche e nelle pratiche per il multilinguismo in Europa.
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
AMANIEUX L., Amélie Nothomb: L’éternelle affamée, Albin Michel, Paris, 2005.
AMANIEUX L., Le récit siamois. Identité et personnages dans l’oeuvre d’Amélie Nothomb, Albin Michel, Paris, 2009.
AMITRANO G., IROIRO. Giappone tra pop e sublime, DeA Planeta, Milano 2018.
AZRA J.-L., Les Japonais sont-ils différents?, Connaissances et Savoir, Poland, 2011.
BALBONI P., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET, 2015.
BAUMAN Z., La vie liquide, PLURIEL, Paris, 2013.
BENZO V., DI GREGORIO G., Business English and Business French: a comparative analysis of teaching methods and job opportunities. International journal of language, translation and intercultural communication, Vol.4, n.1, 2016, p.78-88.
GALISSON R., Cultures et lexicultures. Pour une approche dictionnairique de la culture partagée,
Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, Année 1988, Ann. 7, pp. 325-341.
HALL S., CERVULLE M., Identités et cultures: Politiques des cultural studies, Editions Admsterdam, Paris, 2017.
LADMIRAL J.-R., LIPIANSKY E.M. et al., La Communication interculturelle, Les Belles Lettres; 4e édition, 2015.
LOU J.M., Le Japon d’Amélie Nothomb, Paris, L’Harmattan, 2011.
MATTELART A., Diversité culturelle et mondialisation, Editions La Découverte, Paris, 2017.
NARJOUX C., Étude sur Stupeur et tremblements, Ellipses, Paris, 2004.
NOTHOMB A., Stupore e tremori, a cura di B. Bruno, Voland, Collana Amazzoni, Roma, 2020.
NOTHOMB A., Stupeur et tremblements, Magnard, Paris, 2007.
PRETCEILLE M. A., L’éducation interculturelle, PUF, Que sais-je ?, Paris, 2017.
STETENFELD N., Stupeur et tremblements, Analyse d’œuvre, Profil Littéraire, Bruxelles, 2017.
SITOGRAFIA
http://www.lcm.unige.it/polyphonie/
https://www.dei.unict.it/didattica/linternazionalizzazione-delle-imprese-e-le-lingue-straniere
FILM
Stupeur et Tremblements, film d’Alain Corneau, France 2003.
1 http://www.lcm.unige.it/polyphonie/
2 British Council (2012), Language Rich Europe. Tendenze nelle politiche e nelle pratiche per il multilinguismo in Europa, p.15.
3 Do.Ri.F : Centro di documentazione e di Ricerca per la Didattica della. Lingua Francese nell’Università Italiana, cf. www.dorif.it
4 L’Università di Catania ha approfondito il tema “Plurilinguismo e mondo del lavoro”, dando vita anche ad una rubrica radiofonica in cui diversi imprenditori, docenti, responsabili di istituzioni sono stati intervistati.
5 https://www.dei.unict.it/didattica/linternazionalizzazione-delle-imprese-e-le-lingue-straniere
6 Benzo V., Di Gregorio G., Business English and Business French: a comparative analysis of teaching methods and job opportunities. International journal of language, translation and intercultural communication, Vol. 4, n.1, 2016, pp.78-88.
7 P. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET, 2015.
8 Ibidem, p.144.
9 R. Galisson, Cultures et lexicultures. Pour une approche dictionnairique de la culture partagée,
Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, Année 1988, Ann. 7, pp. 325-341.
10 Ibidem.
11 Un lottatore non dovrà mai mostrare dei segni di sottomissione (trad. it.)
12 Z. Bauman, La vie liquide, PLURIEL, Paris, 2013.
13 G. Amitrano racconta questo rito, raccontando una sua esperienza personale. Cfr. G. Amitrano, IROIRO. Giappone tra pop e sublime, DeA Planeta, Milano 2018, pp.53-64.
14 A. Nothomb, Stupeur et Tremblements, Magnard, Paris, 1999, p.19.
15 Ibidem, p. 22. Nella versione italiana, A. Nothomb, Stupore e tremori, Voland, Collana Amazzoni, Roma, 2020, p.16: “Si calmi. L’ordine non veniva da lui. Trasmetteva le istruzioni del signor Omochi. Non aveva altra scelta. […] che vuol farci? È il vicepresidente. Noi non siamo nessuno”.
16 Ibidem, p. 24. Nella versione italiana, a p.18: “era necessario che avessi l’aria di occuparmi di qualcosa”.
17 Lo stupore e i tremori.